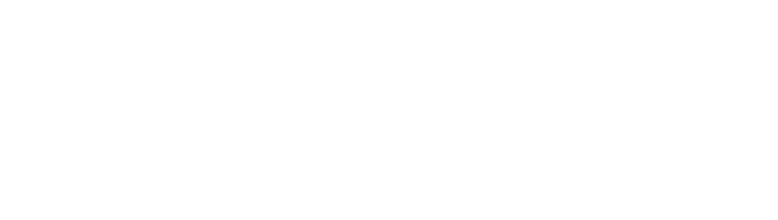Figli che uccidono
La violenza, come sappiamo, è una delle manifestazioni dell’agire umano che si esprime non solo nelle relazioni interpersonali, ma soprattutto nei contesi più allargati che costituiscono il tessuto sociale. Il primo nucleo, il primo contesto nel quale essa ha la possibilità di manifestarsi è senza dubbio quel crogiuolo di relazioni che viene definito famiglia. Il nucleo familiare pertanto va considerato come un microcosmo che comprende e porta con sé un insieme di problemi non solo individuali, ma soprattutto interpersonali. La letteratura ci insegna che possiamo considerare la famiglia come un luogo – dimensione nella quale questo tessuto di relazioni si manifesta sia in maniera “funzionale” sia in modo “disfunzionale”. I sentimenti più profondi trovano così posto e modo di esprimersi. Tra essi quei così detti sentimenti positivi che favoriscono e cementano l’unione tra i componenti del nucleo familiare quali ad esempio, l’affetto, il prendersi cura reciprocamente, l’amore. Ma consentono anche l’espressione dei così detti sentimenti negativi, che vanno dal distacco emotivo alla diffidenza, all’ostilità, sentimenti che generano rabbia e si manifestano attraverso forme sempre più gravi di aggressività fino ad esitare in veri e propri atti violenti.
L’atto violento per eccellenza, interdetto fin dalle indicazioni bibliche, è quello di non uccidere, non uccidere il proprio simile. Dunque se vi è stata la necessità storica di interdire questo tipo di azione è evidente che essa fa parte quasi in modo inspiegabilmente naturale di un desiderio che è proprio nell’essere umano. Dunque uccidere rappresenta una, forse la più terribile, delle azioni mediante la quale si esprime un soggetto. Uccidere non significa soltanto o semplicemente eliminare fisicamente un altro essere, sopprimere una vita ma soprattutto vuol dire negare il futuro, la continuità di quella vita. Significa mettersi dalla parte del Nulla, che dobbiamo immaginare come quella forza contraria alla vita che continuamente cerca di annientarla. Ma uccidere significa anche simbolicamente sostituirsi al Creatore, assumendo per sé quella speciale onnipotenza che ne fa il principio e la fine di tutte le cose. In termini più semplici, nell’uccidere il soggetto che compie il gesto, si sostituisce a Dio. Ma in termini psicologici non dobbiamo dimenticare anche una risposta emblematica data da uno psicopatico serial killer, una volta interrogato sul che cosa provasse nell’uccidere le sue vittime. La sua risposta fu “ritrovare una strana ed astratta tranquillità”. Che paradosso interessante: per ritrovare una mia forma di tranquillità, devo eliminare un altro essere umano.
In fondo chi di noi non ha mai desiderato nella vita eliminare fisicamente un “nemico”? O anche semplicemente un avversario? Chi di noi non ha desiderato di difendersi da qualcuno che si mostrava pericoloso per la nostra sopravvivenza o anche semplicemente un ostacolo per il nostro successo? Ognuno di noi però, anche se ha per un attimo, coltivato questa immagine, sente in modo talmente forte il comandamento che gli vieta l’azione, da non passare all’atto. Se è vero che nel mondo animale l’uccisione avviene per il bisogno della nutrizione che garantisce la sopravvivenza, ed è quindi un’azione che fa parte paradossalmente del ciclo della continuità della vita, nella specie umana, uccidere non ha mai questa funzione specifica, ma rappresenta piuttosto un desiderio incoercibile di sostituire la propria presenza nel mondo alla presenza dell’altro. Quando l’uomo uccide in maniera diffusa, nelle azioni di guerra, l’uccisione viene “giustificata” e “consentita” da un principio superiore, che va dalla difesa della propria etnia, razza, religione, territorio ricco di risorse naturali, e pertanto viene considerato un gesto consentito se non addirittura necessario. Ma noi non tratteremo questo aspetto della natura umana, bensì ci soffermeremo su quello più forte che è l’egoistico bisogno di sopraffazione.
Nell’ambito del contesto famiglia di cui ci stiamo occupando, il tema dell’uccisione del proprio simile incontra ulteriori articolazioni. Esso si manifesta innanzitutto come una rivolta contro le figure genitoriali e/o di attaccamento e per attuarsi deve frantumare un ulteriore tabù. Quello della verticalità. Se nell’uccidere il mio simile, simbolicamente uccido chi mi sta alla pari, chi è sullo stesso piano nell’identità umana, nell’uccidere un genitore non solo devo superare e violare l’interdetto biblico, ma anche quello di togliere la vita a chi mi ha dato la vita. É il gesto che più di ogni altro offende la nostra condizione di esseri umani. Ma distinguiamo a questo punto, i due aspetti del tabù infranto: quello semplicemente legato al comandamento che dice “non uccidere” e quello legato la superamento del dislivello con chi mi ha dato la vita. Uccidere il padre è l’atto che esprime l’ΰβρισ (dal greco “tracotanza”) di chi cancella il λογος (dal greco “principio, orientamento”) che è il principio che orienta, la forza ordinatrice, la guida verso la realizzazione di sé. Il padre ne è portatore simbolico e concreto. Se è vero che “uccidere il padre”, come atto simbolico significa superare nell’evoluzione personale il livello raggiunto dal padre, ucciderlo realmente significa di fatto negarsi la possibilità di questa evoluzione. È come segare il ramo su cui si sta seduti, perché l’azione violenta annienta in primis l’aspetto razionale di chi la commette. Facendolo piombare nella condizione indistinta di chi ha perduto la sua identità. Questo ci farebbe pensare che necessariamente chi commette questo tipo di azione deve essere ricondotto e/o collegato ad una patologia. Come vedremo, non sempre è così. Vi sono alcuni casi in cui la soffocante presenza del padre che invade la vita del figlio fino a non consentirgli uno sviluppo se non nei termini di una identificazione con sé stesso, produce un accumulo di rabbia che può esprimersi in una fase di difficoltà ed alterare il normale sviluppo del soggetto. Fino a commettere un’azione di ribellione talmente violenta da esitare nella necessità estrema della eliminazione fisica dell’altro, per la mia sopravvivenza.
Uccidere la madre invece rappresenta la negazione di quel mondo che ci collega profondamente all’emozione, all’affettività e al principio che nutre. Da un punto di vista non soltanto fisico, la madre è di fatto ciò che mi contiene e mi fa crescere: è nel suo ventre che cresco prima di crescere nel mondo come soggetto autonomo. Ma anche una volta nato, cioè uscito fisicamente da qual contenitore, la sua attenzione su di me, mi accompagna trasformandosi in un’immagine interna che nutre e sostiene i miei passi fino alla fine. La madre trasmette pertanto il senso della continuità degli affetti, trasmette il nutrimento che consente lo sviluppo ed è il riferimento più certo per le nostre emozioni. Ecco perché, in quei casi in cui si uccide una madre l’atto rappresenta fondamentalmente il rifiuto delle capacità relazionali emozionali, ed affettive del soggetto. La madre intesa come “contenitore” dunque è l’elemento più difficile da affrontare nella nostra vita, poiché rappresenta simbolicamente la capacità che noi avremo di essere in relazione con gli altri pur essendo fisicamente separati dagli altri. Possiamo pensare anche che uccidere la madre possa simbolicamente rappresentare un tentativo di sconfiggere la morte. Poiché se è vero che la madre mi ha contenuto in grembo e mi ha dato la vita, posso pensare alla morte come una madre che mi terrà con sé per sempre. Non sembra pertanto un caso che la morte sia un vocabolo femminile: essa infatti, sarà “il contenitore che mi terrà nell’eternità”.
E allora che cosa si agita nella mente di chi uccide un genitore? Poiché tutto ciò che mi contiene è come una parete, un diaframma tra me e il mondo, e la vita e poiché per essere me stesso devo staccarmi da ciò che mi ha dato forma, nutrito, orientato… ma anche mi ha tolto il respiro, mi ha malamente indirizzato, ha negato quello che veramente sono e/o sento di essere. Come potrò superare tutto ciò in forma soltanto simbolica? Con queste osservazioni non si vuole certamente giustificare l’azione delittuosa in sé, ma soltanto tentare di spiegarne i meccanismi profondi che l’hanno determinata. Possiamo inserire questo tipo di azioni in quei tentativi di ribellione nei confronti di una dignità violata, di uno statuto negato, del senso di impotenza che tutto ciò causa, ma non quando si manifesta attraverso le normali frustrazioni somministrate in ambito formativo ed educativo, soltanto quando in definitiva rappresentano una costante di rifiuto e di negazione della realtà dell’altro.
In questo quadro uccidere sembra essere un atto legato al senso dell’identità. Ovvero al suo disconoscimento. Uccidere mi restituisce “quella mia identità negata”. È la protesta più alta che può fare un soggetto per dire: io esisto, esiste il tormento con il quale non posso più convivere, del mancato riconoscimento di quello che sono. Certo è un atto definitivo. Certo non si inserisce in un dialogo sia pure forte che sta alla base di una relazione normale ed evolutiva, certo nega il futuro, il proseguimento della vita con tutte le sue possibilità; ma dal punto di vista psicologico, è anche la risposta di un figlio che vive la ferita generata dalla distanza emotiva del genitore come un legame che lo conduce ad una insostenibile disperazione. Possiamo pensare che il suo gesto assume la funzione di colmare lo spazio del rifiuto. Possiamo considerare il rifiuto come una delle principali fonti del maltrattamento interpersonale. E di un maltrattamento protratto nel tempo si trasforma in una vera e propria situazione di abuso. Quando questo quadro si sviluppa all’interno di una famiglia si sviluppa, si sviluppa nel soggetto che subisce questo trattamento una vera e propria sindrome dell’identità violata. Da una ricerca effettuata, risulta che il 90% degli omicidi commessi sono risultati reattivi, cioè una vera e propria forma di autodifesa da una situazione di abuso intrafamiliare[1]. Ovviamente bisogna dire con forza che non tutti i soggetti maltrattati arrivano ad uccidere i loro aguzzini, siano essi fisici o morali. Assume un aspetto molto significativo il fatto che tutti coloro che arrivano a commettere un gesto così forte lo fanno in uno stato di impulsività, in quell’area che è al confine tra la consapevolezza dei propri gesti e la totale incoscienza di sé, ma soprattutto senza premeditazione. Quando per lungo tempo si cova e cresce una rabbia ed una aggressività che non riesce più ad essere contenuta nemmeno in quelle ordinarie attività di scarico (es. palestra, ballo, attività sessuale, ecc.), all’improvviso si inseriscono aspetti emotivi ed irrazionali del tutto casuali. É il momento in cui la lucidità e il controllo lasciano il campo e si produce l’agito violento.
Per crescere l’essere umano non ha bisogno soltanto degli elementi chimico fisici, naturali, come ad esempio accade con una pianta (che ha bisogno della sua terra, dell’aria che la circonda, dell’acque che la nutre e del sole che la riscalda). L’essere umano ha un bisogno estremo di riconoscimento. Di essere riconosciuto soprattutto nella sua specifica soggettività, il che vuol dire essere riconosciuto proprio per quelle caratteristiche che lo rendono quel tipo di soggetto, al di là del fatto che condivide con gli altri esseri umani l’esperienza di un corpo che si muove nello spazio e nel tempo. Il riconoscimento di sé significa che il soggetto può assumere una consapevolezza del senso, e del significato che assume la sua vita e lo fa attraverso una serie di condizioni che vanno dall’esser neonato, bambino, adolescente, adulto, ma anche dalla corrispondenza che queste condizioni trovano nei ruoli sociali che man mano egli dovrà assumere. Il primo contesto nel quale dovrebbe avvenire questa forma di riconoscimento, è proprio quel contesto familiare, del quale parlavamo prima. Se all’interno di questa dimensione il soggetto non può sviluppare quella consapevolezza di sé che nasce dalla fiducia fondamentale di essere accettato completamente dai suoi genitori, di essere sostenuto, incoraggiato, soprattutto di essere riconosciuto per quello che veramente è, si istaurerà nel soggetto una dolorosa percezione di inadeguatezza. L’inadeguatezza può essere anche un transitorio momento di difficoltà quando ad esempio non mi sento allo stesso livello nel gruppo di riferimento, ma quando diventa una condizione stabile e si potrebbe dire “tragica” che si traduce in una percezione di sé costantemente fallimentare, errata, quella disperazione diventa uno stato costante di sofferenza dal quale il soggetto, per non esserne schiacciato, deve a tutti i costi liberarsi. È la condizione propria della vittima, di chi è cioè vittima del potere di un altro essere.
Come sappiamo la condizione di vittima ci può spingere anche all’auto-annientamento psicologico forzandoci nella costruzione di una identità falsificata. In un gioco terribile, ma sottile, il soggetto arriva a dubitare di sé stesso, di qualunque azione, di qualunque pensiero, di qualunque progetto. Quando questa condizione diventa stabile dentro di sé, ho poche vie di uscita. La prima è trasformarsi passivamente in quello che richiede la volontà dell’altro e identificarsi con quell’immagine che l’altro vuole da me. Questa condizione protratta nel tempo può condurre perfino al suicidio. Oppure per uscire dal tormento di questa condizione di falsificazione, il soggetto è costretto ad eliminare fisicamente dalla propria vita, la presenza dell’altro che lo tiene in uno scacco continuo. Solo raramente il soggetto riesce a ritrovare una sua strada e a vivere per quello che veramente egli è.
BIBLIOGRAFIA
De Leo G., & Bollea G., (1988). Il parricidio in età evolutiva, In Ferracuti F., (a cura di), Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria forense, Vol. VII, Milano; Giuffrè Editore, pp. 131-148.
Fargnoli A., Moretti S., Scardaccione G., (2010). La violenza. Le responsabilità di caino e le connivenze di Abele, Alpes Italia, Roma.
Ingrascì G., & Picozzi M., (2002). Giovani e crimini violenti. Psicologia, psicopatologia e giustizia, Milano: McGraw-Hill.
Lessio S., (2000). La violenza dei minori nei confronti dei propri genitori, in Psichiatria generale dell’età evolutiva, 37(2), pp.209-230.
[1] Reperibile su http://www.poliziadistato.it/poliziamoderna/7_2002/speciale.htm