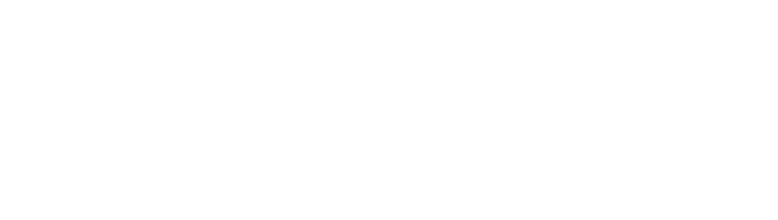Burn-Out e strategie di prevenzione in ambito penitenziario minorile
Il presente contributo nasce quale elaborazione conclusiva e restitutiva del corso interdisciplinare Koinonia. SaperEssere-SaperFare: il Burnout, evento formativo organizzato dall’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici durante l’A.A. 2015-2016, in collaborazione, tra gli altri Enti istituzionali, con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Centro Giustizia Minorile per la Toscana ed Umbria. Il corso si è posto l’obiettivo di formare, attraverso adeguati elementi di conoscenza, gli operatori che intervengono sia nel settore socio-educativo-sanitario sia coloro che svolgano una professionalità nell’area della relazione d’aiuto in contesti caratterizzati da alto livello di Stress.
Nello specifico il contributo si concentrerà sul fenomeno del Burn-out, quindi, alla relazione d’aiuto che s’istaura tra i minori e gli operatori penitenziari, ma anche alle strategie di prevenzione da poter attivare. La scelta di dedicare, all’interno del percorso formativo, uno spazio di conoscenza del contesto penale, in generale e nello specifico di quello minorile, trova la sua motivazione in un duplice obbiettivo: raccontare una realtà disconosciuta ai più e, nel contempo, focalizzare i rischi del Burn-out in modo così evidente come solo in un sistema chiuso essi si rappresentano. Si intende pertanto offrire elementi e spunti di riflessione utili a definire le linee di indirizzo sulle strategie percorribili in ambito formativo, per un recupero e un rinforzo della motivazione degli operatori, in modo da accrescerne il grado di allineamento agli obiettivi che l’Amministrazione, nelle sue articolazioni organizzative, si prefigge.
La sindrome del Burn-out
La sindrome di Burn-out è un insieme di sintomi che esprimono l’esplicarsi di una condizione di ‘distress’ psico-comportamentale a carico di tutte quelle che oramai sono considerate helping professions: tra queste in particolare il personale sanitario (es. medici, infermieri, psicologi), come anche insegnanti ed educatori, assistenti sociali, nonché le Forze di Polizia.
Nel suo stadio più grave e conclamato il Burn-out si esprime tramite un totale disinteresse rispetto all’attività lavorativa accompagnato da una sintomatologia psico-fisica di diversa gravità che può diventare, se non riconosciuta e curata dovutamente, uno stato cronico. La sua sintomatologia del è ciò che accomuna tutte le suddette diverse professionalità: in via esemplificativa i sintomi più comuni e ricorrenti sono ad esempio mal di testa, contratture muscolari, ipertensione arteriosa, depressione, disturbi gastrointestinali, insonnia etc.
Tale sindrome si manifesta pertanto come una particolare forma di reazione emotiva, psico-corporea e cognitivo-comportamentale, concretizzata da chi ritiene come emotivamente stressante il contatto continuato nel tempo con persone che si trovano in una situazione di disagio e di sofferenza fisica, psichica o sociale. Il Burn-out è quindi il risultato di una reazione ad uno stress lavorativo e di un relativo non adattamento positivo al lavoro.
Una delle maggiori studiose del fenomeno, C. Maslach, ne ha evidenziato le tre specifiche fasi, ciascuna delle quali contribuisce al manifestarsi delle altre:
- esaurimento emotivo: inteso quale sentimento di vuoto emotivo interiore rispetto al proprio lavoro, contestuale ad un sentore di inaridimento rispetto alle relazione con gli altri;
- depersonalizzazione: deterioramento della relazione con l’utenza che si esprime quale atteggiamento di allontanamento e rifiuto (espresse per lo più con risposte negative e/o sgarbate) esplicitate verso chi riceve e/o richiede un servizio di natura professionale;
- ridotta produttività lavorativa: la negatività espressa verso i terzi esterni si traduce col passare del tempo in agiti negativi verso se stessi, atteggiamenti mossi prevalentemente da rabbia, senso di colpa e frustrazione, incrementando la disistima e l’insorgere di sintomi depressivi.
Da non confondere con lo Stress lavorativo, con il quale ha in comune il deperimento emozionale e la scarsa realizzazione personale, la sindrome di Burn-out se ne allontana invece per lo specifico fattore della depersonalizzazione inteso quale atteggiamento di fredda indifferenza verso l’utenza (Carli, Petrabissi, Santinello, 1994).
Nelle helping professions l’insorgere del Burn-out è determinato da fattori psico-sociali, quanto organizzativi: tra i primi ad esempio lo stretto contatto dell’operatore con l’utenza così come il costante e significativo coinvolgimento emotivo nelle problematiche dell’utente, specie se minore in contesto chiuso quale è il carcere. Particolarmente significativo, anche lo stress cronico-giornaliero spesso determinato da precipui elementi organizzativi del lavoro in un sistema rigido. Se da un lato è vero che può sussistere una personale fragilità nel gestire la frustrazione del contesto lavorativo, connessa inevitabilmente alla personalità, alle motivazioni e agli interessi del soggetto, dall’altra sussistono delle specificità organizzative (es. sovraccarico di lavoro, mancanza controllo dei processi organizzativi, scarsa formazione etc..) che possono, in concomitanza con i fattori soggettivi, far determinare l’insorgere di un distress (condizione di disadattamento) e cronicizzarlo, se ripetuto nella quotidianità, in Burn-out.
Il contesto istituzionale penale minorile
Al fine di meglio comprendere il contesto penale minorile è utile realizzare una breve disamina del sistema nel suo complesso, con particolare riferimento ai soggetti istituzionali coinvolti e alle loro funzioni.
Il Ministero della Giustizia, quale centro della politica giudiziaria del governo, è l’organo preposto all’organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale: nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell’ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario, occupandosi pertanto anche dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, istituito dall’art.8 del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55.
In quanto articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia, il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità si occupa della tutela dei diritti dei minori e dei giovani-adulti, dai 14 ai 25 anni, purché il reato sia stato commesso da minorenne: i minori sottoposti a procedimenti penali sono soggetti beneficiari di interventi di tipo preventivo-educativo finalizzati alla promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto col fine ultimo del reinserimento sociale. La specificità del trattamento del minore entrato in conflitto con la Giustizia, che giustifica l’esistenza autonoma di un Dipartimento ad hoc, deriva dalla particolare tutela prevista dalla normativa nazionale e internazionale per i minorenni in quanto soggetti in età evolutiva: tale protezione giuridica implica risposte di giustizia peculiari e in grado di attivare processi di crescita responsabilizzante ai fini del superamento della condotta deviante e nell’ottica del recupero del minore alla legalità e quindi alla società. Per l’attuazione di tali interventi trattamentali sono previste, presso le strutture minorili, più figure professionali, nello specifico educatori, assistenti sociali e personale di Polizia Penitenziaria opportunamente formati al momento dell’ingresso nella Giustizia Minorile e destinatari di una costante attività di aggiornamento professionale.
Il Dipartimento si compone di una struttura centrale, che elabora linee d’indirizzo, attua verifiche sui risultati conseguiti e coordina gli interventi sul territorio nazionale, e alcuni servizi periferici (Centri per la Giustizia Minorile, Istituti Penali per i Minorenni, Centri di Prima Accoglienza, Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, Comunità socio-educative), che si caratterizzano per la loro competenza su base distrettuale (regionale ed interregionale), al fine di valorizzare e meglio utilizzare le potenzialità delle diverse realtà locali. Tutto ciò finalizzato alla realizzazione di un concreto e significativo decentramento teso a riconoscere e a promuovere le specificità dei territori interessati. Lo scopo è di assicurare interventi specializzati per il trattamento dei minori e procedere all’analisi permanente dei fenomeni sociali interconnessi con la devianza e la delinquenza minorili.
Dal Dipartimento per la Giustizia minorile dipendono i 12 Centri per la Giustizia Minorile (CGM) – organi del decentramento amministrativo (ex art. 7 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 272 “Norme di attuazione e coordinamento del D.P.R. 448/88), con competenza sul territorio di più regioni. Essi esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili da essi dipendenti, oltre ad attività di collegamento con gli enti locali, enti pubblici, università e privato sociale.
Ognuno dei 12 Centri opera sul territorio attraverso i Servizi Minorili della Giustizia (ex art. 8 D.Lgs 28 luglio 1989, n. 272) ai quali è affidata l’attivazione di tutti gli interventi destinati al minore (es. interventi di informazione, di conoscenza, di sostegno, di controllo, di raccordo operativo etc..). I Servizi Minorili dell’Amministrazione della Giustizia intervengono – nel quadro dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’ordinamento penitenziario (L. 354/75) e dal relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 230/2000), dalle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni (D.P.R. 448/88) e dalle relative norme di attuazione (D.Lgs. 272/89) – a favore dei minorenni nell’ambito della competenza penale dell’Autorità Giudiziaria Minorile.
Ai Servizi minorili della Giustizia competono gli accertamenti sulla personalità del minore (art. 9 D.P.R. 448/88), e l’intervento durante tutto l’iter penale sia in applicazione delle misure cautelari (articoli 20,21,22,23), che nella fase di esecuzione della pena, nonché nella sospensione del processo con l’applicazione dell’istituto della messa alla prova (articolo 28 del D.P.R. 488/88).
Se questo è il quadro istituzionale-normativo del sistema penale minorile ad oggi in vigore in Italia, per comprendere ‘da dentro’ le problematicità che si possono vivere in un contesto penale minorile, specie negli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) e quindi come possa insorgere la sindrome di Burn-out in oggetto, occorre che si delineino tre elementi: cosa si intenda per Mandato Istituzionale; quale sia la struttura di un IPM e quale la sua utenza.
Il Mandato Istituzionale identifica quel complesso di funzioni che un professionista è tenuto a svolgere sulla base della normativa generale e specifica che informa l’organizzazione alla quale appartiene ed alla quale deve rispondere del suo operato a favore dei fruitori del servizio che eroga. Si può dire che esso è sostanzialmente interagente con il mandato professionale, che esplica invece l’insieme dei principi, dei valori, della metodologia, della deontologia, dei modelli e dei livelli di competenza definiti dalla comunità professionale di riferimento. Il professionista a cui far riferimento è appunto l’operatore penitenziario che nel contesto penale minorile ricopre funzioni e professionalità distinte: oltre al personale della Polizia Penitenziaria ed al Direttore, si annoverano, in numero variabile, i membri dell’organico del personale amministrativo e del personale educativo.
Per tutti questi soggetti risulta pertanto fondamentale affinché non si delinei una sindrome di Burn-out, una corretta definizione e delimitazione delle funzioni, una loro corretta organizzazione quant’anche un effettivo coordinamento professionale.
L’Istituto Penale per Minorenni è invece la struttura organizzativa e fisica entro cui non solo si danno esecuzione ai provvedimenti privativi della libertà emessi da un’Autorità Giudiziaria del Tribunale per i Minorenni (es, custodia cautelare, esecuzione pena, semidetenzione, semilibertà), quanto si realizza un programma personalizzato di recupero e di risocializzazione per il singolo minore utente della struttura, secondo quanto stabilito nell’Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio n. 354/1975) e nel suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 30 giugno n. 230/2000).
L’Istituto Penale per i Minorenni, in quanto carcere, si configura quale “Città dentro la città”: esso mantiene la caratteristica di un’istituzione totale separata e chiusa, tramite un isolamento fisico e simbolico dalla società esterna. In quanto luogo-non luogo è inevitabilmente portata a sviluppare quella che in dottrina viene classificata quale sindrome da “prisonizzazione” o meglio, l’effetto totalizzante che l’esperienza detentiva ha sull’individuo (Porchetti R.[1]). Effetto, quello della prisonizzazione, che sta ad indicare prevalentemente l’assunzione in grado maggiore o minore del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del contesto penitenziario.
Nell’analisi di Clemmer esistono diversi fattori in grado di influire sul processo di prisonizzazione, distinguendo tra fattori universali e fattori individuali, a seconda che siano (i primi) o meno (i secondi) riscontrabili nella totalità dei detenuti. Tra i fattori universali vengono, in via esemplificativa, indicati l’accettazione di un ruolo inferiore; l’acquisizione di dati relativi all’organizzazione della prigione; lo sviluppo di alcuni nuovi modi di mangiare, vestire, lavorare, dormire; l’adozione del linguaggio locale; il riconoscimento che niente è dovuto all’ambiente per la soddisfazione dei bisogni come anche l’eventuale desiderio di un buon lavoro.
L’essere sottoposti a tali fattori basta per rendere un soggetto sì membro della categoria “detenuti”, come anche distruggere la sua personalità, con il risvolto negativo di poter impedire un adattamento felice in altra comunità. Non bisogna trascurare che un certo peso in questo fenomeno di vera e propria modificazione del Sé va dato al tempo di reclusione: un breve periodo di detenzione non pregiudica un nuovo modo di vita senza troppe difficoltà, dal momento che l’integrazione nella cultura carceraria è avvenuta limitatamente ai fattori universali della prisonizzazione, che non sono gli aspetti maggiormente suscettibili di preoccupazione, come invece nel caso delle “influenze che fomentano o rendono più profonda la criminalità e l’anti-socialità e che fanno del detenuto un esponente caratteristico dell’ideologia criminale nella comunità carceraria[2]”.
I fattori individuali che invece possono incidere sull’insorgere di tale sindrome si esprimono quali fattori prevalentemente culturali quali ad esempio la sensibilità alla cultura così come il tipo e il numero di relazioni prima dell’incarcerazione; l’affiliazione o meno a gruppi primari o semi-primari nel carcere (in stretta connessione con i primi due aspetti elencati); come anche, in termini di casuale collocazione in un gruppo di lavoro, in un braccio della struttura o con un compagno di cella; infine l’accettazione o meno dei dogmi e dei codici della cultura carceraria; altri fattori soggettivi non trascurabili sono infine l’età, la nazionalità, la razza, i condizionamenti regionali.
La vita di un Istituto Penale Minorile si svolge sempre nello stesso luogo, seguendo le medesime modalità, purché sotto il controllo della medesima autorità: a tutti è richiesto di fare la medesima cosa alla stessa maniera. La dimensione della cella, a parte i luoghi in comune, è l’unica dove muoversi: la cadenza della giornata è programmata e calcolata nel tempo, pertanto l’isolamento e la privazione di stimoli possono costituire per l’utenza sicuri fattori di stress.
L’esperienza ed i luoghi della detenzione possono inoltre provocare sull’utenza ulteriori specifici effetti. Tra questi in particolare si ricordano:
- l’erosione dell’individualità, intesa come danneggiamento della capacità individuale di pensare e di agire in modo autonomo;
- la deculturazione o discultura, ossia la perdita dei valori e delle attitudini che il soggetto aveva prima dell’ingresso in carcere;
- lo stress da segregazione determinante danni fisici e psicologici che si affliggono sull’individuo durante il periodo della sua permanenza in carcere;
- l’isolamento, la carenza cioè di interazione sociale con il mondo esterno e con gli altri individui chiusi in carcere; infine;
- l’estraniamento, ovvero l’incapacità di adeguarsi alle novità dell’ambiente esterno (tecnologiche, sociali, ecc.) una volta conclusa l’esperienza dal carcere[3].
L’utenza il quadro d’insieme che emerge dallo studio dei flussi di utenza, riferito all’anno 2015, segnala 1.068 ingressi in IPM, avvenuti prevalentemente a seguito di ordinanza di custodia cautelare (63%). Prevalente è il genere maschile nella fascia di età tra i 16 e i 17 anni, tra questi, maggiore è il dato riferito agli stranieri, provenienti nella maggior parte dall’est europeo ed Africa.
Minore è il dato riferito alle femmine, fermo al 15% del totale, prevalentemente straniere, provenienti dalla Bosnia Erzegovina, Serbia, Romania e Croazia. In merito ai reati a carico dei soggetti entrati in IPM, maggiore è quello contro il patrimonio (furto, rapina, ricettazione), a cui segue quello contro la persona (omicidio volontario, lesioni personali volontarie, violenza privata e minacce).
Per una completa comprensione dei dati relativa all’utenza degli IPM, giova ricordare che nell’anno 2014 è stata introdotta una modifica normativa, il D. L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n.117, che all’art. 5 interviene sulla competenza dei Servizi Minorili, con riferimento alla fascia di utenza dei cosiddetti “giovani adulti”, ragazzi che hanno compiuto il reato da minorenni e che, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del processo penale minorile, rimangono in carico ai Servizi minorili fino all’età di 21 anni (art. 24 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 272). Estendendola fino al compimento dei 25 anni, sempre che, per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto anche delle finalità educative.
Ma l’aspetto quantitativo da solo non riesce a dare l’esatta dimensione, in termini anche qualitativi dell’impegno operativo necessario al raggiungimento degli obbiettivi propri dell’istituzione. A questo si deve senz’altro aggiungere aspetti di natura sociologica e personologica, rappresentati dall’utenza in questa emblematica relazione d’aiuto, dove il tutto si concretizza entro il confine delle mura.
Burn-out e contesto carcerario minorile
Vista la natura specifica del Burn-out, è altamente probabile che l’operatore penitenziario più a stretto contatto con il detenuto –sia agente di polizia, quanto educatore– possa sviluppare tale sindrome, non solo per le caratteristiche possedute dalla struttura in cui opera e le peculiarità dell’utenza con cui è a stretto contatto giornalmente, ma anche e soprattutto per il tipo di relazione d’aiuto che questi instaura con i minori utenti.
Carl Rogers ha definito la relazione d’aiuto come “una relazione in cui almeno uno dei protagonisti ha lo scopo di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità ed il raggiungimento di un modo di agire più adeguato ed integrato[4]”. Sono pertanto aspetti caratterizzanti la relazione di aiuto la simmetria, intesa quale reciproca volontà di relazionarsi, così come la sospensione del giudizio, un atteggiamento di rispetto, l’assenza di comportamenti manipolativi e quindi anche la piena autenticità, soprattutto per l’operatore penitenziario. Tutto ciò comporta per quest’ultimo l’acquisizione di una capacità di gestire l’incontro con l’altro in tutto il suo divenire, accogliendo e sopportando la fatica, se non la sofferenza emotiva che lo accompagna, secondo canoni non di un capire razionale, bensì di un sentire autentico e ben più profondo.
La relazione di aiuto con un minore entrato nel circuito penale comporta delle specificità che l’operatore deve sempre considerare: il minore, difatti, non ha scelto liberamente di essere aiutato, spesso non ha consapevolezza dei propri bisogni, dimostrando tanto una radicale difficoltà di comprensione del livello della comunicazione quanto una capacità di strumentalizzare l’intervento dell’operatore, con l’unico fine di uscire il prima possibile.
Tra gli operatori penitenziari quello istituzionalmente deputato alla relazione d’aiuto è indubbiamente l’Educatore: in qualità di membro della segreteria tecnica del gruppo di osservazione e trattamento (art. 29 dell’Ordinamento Penitenziario), l’Educatore è anche Funzionario e Pubblico ufficiale con competenze in ambito disciplinare (art. 40 L. 354 /1975). Per questa sua dicotomia di ruolo connessa al suo mandato istituzionale, l’Educatore quindi è il soggetto che nel contesto carcerario minorile più tra gli altri operatori si espone al rischio Burn-out.
L’operatore penitenziario, in particolar modo l’Educatore, deve sempre tenere presente in che ambito interviene quando si relaziona con l’utente minore: ogni intervento ha una ricaduta sull’intero sistema (tanto organizzativa, quanto relazionale), quindi sarà per lui fondamentale ogni volta effettuare un’attenta valutazione del rischio, proprio perché “la relazione…quando si trasferisce nei luoghi di reclusione, si svolge in un clima difficile, è attraversata da fasi di ansietà, dubbio, a volte di conflitto[5]”.
Le parti della relazione d’aiuto, pertanto, s’incontrano in un contesto di per sé patogeno: se la relazione d’aiuto è di per sé fonte di stress, sia per il proprio vissuto professionale che per il contatto reiterato e prolungato con la sofferenza altrui, è facilmente comprensibile come la stessa sia gravata dalla specificità del contesto d’intervento e dalle problematiche rappresentate dall’utenza che molto spesso toccano ambiti profondi dell’operatore (a fronte di specifici reati).
Il rischio di Burn-out è quindi, quotidianamente presente, dove un eccessivo carico emotivo determina un lento processo di logoramento o decadenza psicofisica dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato. Come di fatti accade in un contesto penitenziario: pertanto si viene a delineare un forte contrasto tra lavoro emozionale[6] e dissonanza emotiva[7], contrasto prodromico, con il passare del tempo, all’insorgere nell’operatore della sindrome di Burnout.
Le strategie di prevenzione
Al fine di definire delle strategie di prevenzione efficaci, si ritiene utile realizzare una disamina delle criticità maggiormente riscontrabili nel contesto carcerario minorile.
Una delle prime criticità è quella del cd ‘doppio legame’ (Bateson G.): con esso si indica la situazione ambivalente dell’operatore penitenziario, situazione tanto di aiuto, quanto di controllo sull’utenza. A tale fattispecie è possibile rispondere, in via di strategia preventiva, con una regolazione del coinvolgimento emotivo in modo da non ricorrere a meccanismi di “identificazione protettiva, o addirittura di negazione delle emozioni di frustrazione, rabbia, dolore e aggressività, che conduce a prese di distanza illusorie e sfociano in atteggiamenti di indifferenza e cinismo, tipici del processo che conduce al Burn-out[8]”.
Da non sottovalutare, come affermava Golembiewsky (1989), la natura processuale del Burn-out che per gli operatori penitenziari si arricchisce di un forte esaurimento emotivo, una evidente depersonalizzazione, quindi una mancanza di realizzazione personale, quali indicatori infallibili della sindrome in esame.
In particolare la depersonalizzazione, quale atteggiamento di rifiuto e freddezza, potrebbe derivare dal tipo di percorso formativo e dal tipo di atteggiamento che gli operatori penitenziari, nello specifico gli agenti, devono mantenere per evitare un maggior coinvolgimento emotivo rispetto all’utenza degli IPM.
Tra gli aspetti determinanti la sindrome di Burn-out la letteratura risulta unanime nel dare rilievo non tanto a determinate variabili (es. titolo di studio, età, differenze di sesso) quanto piuttosto dalla maggiore anzianità di servizio, confermando il fattore ‘tempo’ quello prioritariamente più significativo nell’insorgere di tale sindrome.
Tra le strategie di prevenzione possibili, si possono enucleare tre distinte tipologie: organizzative, di gruppo, del singolo operatore.
Tra le strategie organizzative merita far riferimento prima di tutto alla necessità di poter promuovere un concetto di BenEssere inteso come qualità della vita di una comunità lavorativa, comunità che dovrebbe poter promuovere una costante ricerca di modelli organizzativi più rispondenti alle specifiche caratteristiche di contesto (es. rispetto al carico di lavoro o alle risorse, tanto umane quanto economiche). Altrettanto significative potrebbero essere la sollecitazione di stili comunicativi più reali, espressi sia in senso verticale che orizzontale, in modo da garantire tra gli operatori un maggiore coinvolgimento. Utile a tal fine da parte di ciascun soggetto una piena adesione agli obbiettivi perseguiti dalla struttura, adesione che necessariamente dovrebbe prevedere una preventiva partecipazione alle decisioni da prendere rispetto la vita interna della struttura. Infine, si ritengono da incoraggiare per tutti gli operatori penitenziari non solo un percorso di formazione permanente volta ad accrescere il bagaglio professionale con nuove tecniche e competenze operative; quanto garantire un’attività di sostegno/consulenza (es. counseling), come anche di supervisione continuativa. Supervisione da intendersi come individuale e di gruppo, tanto interna, con specifica selezione del personale direttivo alla funzione, quanto esterna, realizzata da esperto, ma altresì prevedere una modalità congiunta, interna ed esterna, al fine di meglio esplorare le antinomie interne, poterle quindi esplicitare e, se possibile, risolvere.
Tra le strategie di prevenzione di gruppo risultano sicuramente vincenti, la previsione all’interno della vita della struttura di momenti di confronto reciproco (es. gruppi auto-aiuto), utili contesti dove il vissuto emozionale può essere condiviso e risolto, non depositandosi nell’intimo di ognuno, in attesa dell’attimo esplosivo. Non si deve dimenticare la natura processuale del Burn-out, quanto anche la consapevolezza di quanto esso non sia causato dalle emozioni, piuttosto dall’impossibilità di esprimerle, condividerle e quindi elaborarle. Individuare, quindi, degli spazi e dei tempi per esprimere i vari vissuti emotivi, permette all’operatore di sviluppare un profondo e sempre rinnovato senso di appartenenza, utile per evitare la depersonalizzazione ed il senso di distacco prodromici del Burn-out.
Rispetto alle strategia di prevenzione applicabili al singolo operatore sicuramente può essere d’ausilio l’acquisizione o la riacquisizione della motivazione nella scelta della professione e delle aspettative riposte, in modo da scongiurare non solo la cd “fantasia del salvatore”, quale sindrome di co-dipendenza affettiva che può instaurarsi tra operatore ed utente, come anche l’affermarsi della cd “mistica professionale” (Edelwich e Brodsky, 1980), particolare stadio iniziale di forte entusiasmo e che insorge nell’operatore dalla convinzione che al possesso del titolo professionale corrisponda matematicamente una competenza professionale.
Alla luce di tutto ciò è molto importante implementare nel singolo operatore non solo una consapevolezza reale dei propri limiti (in particolare rispetto l’intolleranza alle frustrazioni, in modo da evitare un eccessivo coinvolgimento), quanto anche incentivare la disponibilità a cercare aiuto, qualora ce ne fosse la necessità, ma anche possedere gli strumenti conoscitivi per riconoscere, se possibili ai primi stadi, l’insorgere di tale sindrome.
Conclusioni
Il fenomeno del Burn-out appare ancora poco conosciuto, se non del tutto sottostimato in particolare dagli stessi operatori delle cd help professions: come già detto, tale sindrome è un processo evolutivo che si afferma quando i livelli di stress professionale sono eccessivi e prolungati, pertanto si tratta di una patologia professionale molto articolata e connessa ad una molteplicità di fattori. I Servizi operanti nel contesto sociale dovrebbero poter investire risorse per prevenire tale fenomeno soprattutto partendo dalla considerazione che il Burn-out non è una questione legata al singolo individuo, ma è una fenomenologia di un disagio di un intero sistema lavorativo. Utile quindi poter costituire, in ogni unità organizzativa, un gruppo di lavoro che possa offrire uno specifico supporto interdisciplinare agli operatori che potrebbero così trovare modalità e strumenti per comunicare e condividere lo stress, rielaborando e reintegrando l’energia emotiva esaurita.
La prevenzione pertanto rimane pur sempre la migliore forma di investimento non solo nel breve, ma anche nel lungo periodo. Ne consegue, più di ogni altra cosa, la necessità di porre in essere interventi interdisciplinari, sia di formazione, quanto di gestione e supervisione, in modo da evidenziare degli orientamenti strategici chiari, utili per realizzare una corrispondenza nei singoli contesti lavorativi tra linee d’azione specifiche e gli obiettivi da esse perseguite.
La prospettiva che si intende pertanto promuovere è quella di pensare a strategie di prevenzione che implementino uno sviluppo organizzativo volto a concretizzare luoghi di lavoro sani ed efficaci, in modo da apprendere e riconoscere quali forme organizzative, quali modelli e processi influiscano su le motivazioni, la soddisfazione, l’efficacia del singolo lavoratore (Figiani, Giambalvo, Lucido, 2007). Tale prospettiva si fonda pertanto sul riconoscimento della capacità degli individui di auto-motivarsi grazie all’attivazione di risorse interne, connesse alla soddisfazione di esigenze di crescita, riconoscimento personale, ma anche acquisizione di consapevolezza di un Sé che sia integrato al tessuto professionale condiviso e partecipato.
Bibliografia
Avallone F., Paplomatas A.,(2005), Salute organizzativa. Psicologia del benessere nei contesti lavorativi, Raffaello Cortina Editore, Milano.
Bateson G.,(1989), Mente e natura. Un’unità necessaria, Adelphi, Milano.
Buffa P.,(2001), La giustizia quotidiana in carcere. Disuguaglianze, paradossie riforme auspicabili, in “Animazione Sociale”, Maggio.
Ceraudo F., (\988), Principi fondamentali di medicina penitenziaria, Servizio Editoriale Universitario, Pisa.
Chauvenet F., Orlich G., Benguigui, (1994), Le monde des surveillants de prison, Presse Universitaires de France, Paris.
Clemmer D., (1997), La comunità carceraria, in Carcere e società liberale (Santoro E.), Giappichelli, Torino.
Fimiani D., Giambalvo M., Lucido S. (NEXT – Nuove Energie X il Territorio), (2007), Ricerca-Intervento e ciclo di formazione sul fenomeno del burnout nel Corpo della Polizia Penitenziaria, Palermo.
Freudemberger H.J., (1974), Staff Burnout, in J. of Social Issues, 30 (1).
Goffman E., (2001), Asylums. Le Istituzioni totali, Edizioni di comunità, Milano.
De Martino M , (2007), Tre approcci possibili al contesto penitenziario in Brunei C., Sapia C., (a cura di) “Psicologia penitenziaria”, Edizioni Scientifiche Italiane.
Ministro della Funzione Pubblica, Direttiva n. 80 sulle misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni, Roma, (2004).
Maslach C., Leiter M.P., (2000), Burnout e organizzazione. Modificare i fattori strutturali della demotivazione al lavoro, Erickson, Trento.
Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Piano della Formazione 2007, con le linee guida di programmazione della formazione per il triennio 2007-2009.
Next – Nuove Energie per il Territorio, (2005), Report finale della ricerca intervento e ciclo di formazione sul burnout della polizia penitenziaria.
Olivero F., Osmani I. _ S.R.F. (a cura di), (2005), Iniziativa mirata a supportare gli operatori esposti a situazioni stressanti e fonti di burn out, Torino.
Orsenigo A., (2005), Formazione risorsa critica nella nostra società, in “Spunti. Semestrale per la ricerca e l’azione nelle organizzazioni”, Ottobre 2005,anno VI, N. 8.
Pasquali S., Innovare le Amministrazioni, in Le due città, Rivista dell’Amministrazione Penitenziaria, N. 2 Anno IX.
Pasquali S., (2008), Ricerca sul Burnout degli operatori penitenziari, in Rassegna Penitenziaria, Bologna.
Porchetti R., (2016), Il Carcere: tra rischio prisonizzazione e prospettive di recupero sociali, in Profiling-I Profili dell’abuso, https://www.onap-profiling.org/il-carcere-tra-rischio-di-prisonizzazione-e-prospettive-di-recupero-sociali/.
-
Porchetti R., Il Carcere: tra rischio prisonizzazione e prospettive di recupero sociali, https://www.onap-profiling.org/il-carcere-tra-rischio-di-prisonizzazione-e-prospettive-di-recupero-sociali/ ↑
-
Clemmer D., La comunità carceraria, in Carcere e società liberale (Santoro E.), Giappichelli, Torino, 1997, pag. 208. ↑
-
Ceraudo F., Principi fondamentali di medicina penitenziaria, Servizio Editoriale Universitario, Pisa 1988, p. 149. ↑
-
Rogers C., La terapia centrata sul cliente, Giunti ed, 2013. ↑
-
Goffman E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Piccola Biblioteca Einaudi, 2010. ↑
-
Il concetto di lavoro emozionale, venne proposto per la prima volta da Hochschild (1983) e venne successivamente ampliato e ridefinito da altri autori (Ashforth & Humphrey,1993; Morris & Feldman,1996; Grandey, 2000) nelle sue dimensioni, antecedenti e conseguenze, generando una ampia teorizzazione del medesimo costrutto. L’autrice definisce il lavoro emozionale, differenziandolo da quello fisico e cognitivo, come un “lavoro che richiede di indurre o sopprimere un sentimento al fine di sostenere un espressione esteriore che produca uno stato mentale in un altro, in questo caso il sentimento di sentirsi protetti in un luogo sicuro”. ↑
-
La dissonanza emotiva è intesa come la discrepanza tra le emozioni realmente provate e quelle espresse per soddisfare le display rules (Hochschild, 1983; Rafaeli & Sutton, 1987). La dissonanza emotiva è oggetto di ricerche empiriche che si sono concentrate soprattutto sulle sue conseguenze che questa genera sui lavoratori, è sostenuto come possa essere un fattore stressante che ha un effetto negativo sugli esiti lavorativi. Morris e Feldman (1997) ad esempio, hanno trovato una relazione positiva significativa tra dissonanza emotiva e burnout. ↑
-
Pasquali S., Ricerca sul Burnout degli operatori penitenziari, in Rassegna Penitenziaria, Bologna, 2008, pag.112, http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/96.pdf . ↑