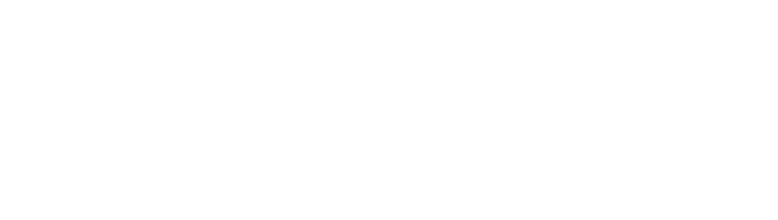Donne spalmate di buio
Ogni sera era sempre uguale. Buio. Due fari accecanti. Buio di nuovo. A lungo. Suoni indefiniti di una periferia senza nome. Che nulla avevano a che fare con i ritmi traboccanti di vita della mia terra. “Ehi, Edoway, si è fatta sera”. “Si è fatta sera”. Anche il saluto di Afi e quello di Adjoa, compagne spalmate di buio come me, era diventato soltanto un accessorio alla strada nera lungo la marina, da due anni attaccata al mio destino come una mignatta.
Ero sola. In attesa. In attesa di qualcosa di buono, che sapevo però non sarebbe mai arrivato. In attesa soprattutto dell’ennesimo cliente, quello arrivava sempre, e dell’ennesimo scambio di merce, il mio corpo per trenta euro. Durava poco in fondo. Ogni volta lo schifo disperato riuscivo a buttarlo in un angolo in fondo in fondo. In quei momenti bastava non pensare, mandare la testa altrove, magari al sole rosso che prima di andare a dormire si nascondeva dietro i rami immensi degli alberi che sfilano sul fiume Adédjé. E quando tutto era finito, avevo versato un’altra goccia nel mare del debito con Madame.
Ah Madame, ce l’aveva fatta a fregarmi. “Ti porterò a studiare in Europa. Realizzerò il tuo sogno, via da questa miseria, da questa polvere e da questi campi ingrati”. E come era stato felice mio padre a quelle parole. “Hai visto Edoway, hai trovato chi ti porta in Europa. Andrai in Italia come le ragazze fortunate”.
E poi i vestiti, le parrucche che piacevano a me. Le scarpe con il tacco alto e il rossetto lucido, lo smalto per le unghie. “Tieni, prendi questi soldi e compra quello che vuoi, devi essere bella. Le donne devono essere belle per piacere agli uomini”. Madame sapeva parlare all’inizio, sapeva allettarti con le sue seduzioni, farti intravedere un mondo che sembrava così facile così raggiungibile. Così stupendo.
Non afferrai a cosa servisse essere belle per studiare. Ma lo capii in una giornata. “Studiare? E tu hai creduto davvero che ti portassi via gratis dalla melma per farti venire a studiare? Povera ragazza. Chi saresti tu per avere da me un regalo simile?”. La voce di Madame arrivò implacabile. Furono tutte frustate.
Chi ero io? Nessuno. “Vai, vai in camera e infilati i vestiti che hai comprato con i miei soldi. I miei soldi capito? Ora viene a prenderti Mambo e ti dice cosa devi fare. Mettiti l’animo in pace carina, e comincia a lavorare come le altre. Prima lo fai, prima inizi a darmi quanto mi devi. Ficcatelo bene in quel cervellino da pulce: il marciapiede non lo lascerai finché non mi avrai restituito tutto fino all’ultimo centesimo. Anzi, ti auguro di non essere ancora vergine. Altrimenti dovrai pagare anche Mambo per farti il servizietto prima di mandarti in strada. E il conto sale”. Ero vergine.
Piansi. Urlai. Mi disperai. Fui lasciata due giorni interi senza mangiare e senza bere. Rimasi chiusa in camera. “Ancora due giorni di questa cura e poi lo vedi come corri sulla strada”. Madame aveva ragione. Mi apriva la porta e mi diceva “Vai. Vuoi andare? La porta è aperta. Ma ricordati di quello che ti aspetta là fuori se disobbedisci al Woodoo”.
Mi resi conto di non avere scampo. A casa non potevo tornare perché la prima cosa che aveva fatto Madame appena messo piede in Italia, era stata quella di portarmi via i documenti e chiuderli a chiave in un cassetto. E poi, comunque, sarei stata perseguitata dallo spirito Ogu fino alla morte, atroce e vicina. No, il Woodoo non si può tradire.
Il terrore vinse. E il giorno dopo ero sul marciapiede: minigonna, tacchi a spillo e un vortice dentro, più scuro e limaccioso dell’acqua dell’Adédjé in piena quando, gonfio, si trascina dietro i tronchi e i cadaveri degli animali.
Era stato mio padre, su suggerimento di Madame durante una delle sue trasferte nigeriane programmate per reclutare un po’ di carne fresca – ma noi allora non lo sapevamo ‑ a portarmi dalla sacerdotessa per capire se il viaggio in Italia sarebbe stato propizio e comunque per favorirlo con i riti sacri Woodoo.
Quella mattina io e lui partimmo all’alba dal villaggio diretti alla casa di Gbedè, la strega, che si trovava fuori dal centro abitato. Alle spalle ci lasciammo le capanne di terra rossa intarsiate di pietre, coperte di paglia e affondate nella chioma verde arruffata del bosco e infilammo una strada sassosa. Un tratto lo facemmo in auto ma poi dovemmo proseguire a piedi perché la vegetazione folta, oltre la quale sorgeva l’abitazione della donna che ci aspettava, si faceva attraversare a malapena da un uomo, figuriamoci da un’auto.
Eravamo già tutti sudati quando arrivammo finalmente alla radura e alla capanna.
La sacerdotessa ci accolse sulla porta e ci pregò di toglierci i sandali e lasciarli all’ingresso. Nella stanza le pareti erano coperte da maschere, pugnali e machete. Si imponeva alla vista un altare scarno circondato da immagini sacre e un numero imprecisato di bottiglie, di lato una piccola vasca piena d’acqua e al centro della stanza un buco dal diametro di circa un metro, una specie di pozzo senza spalletta di cui era impossibile vedere il fondo.
Dopo averci fatto accovacciare sulle pelli di mucca distese sul pavimento di terra battuta, la donna prese una mezza zucca piena di acqua e iniziò a pregare dapprima con voce tremula poi ferma e a chiamare lo spirito: “Ogu, Ogu, ti chiamo, la tua serva e padrona Gbedé ti chiama. Vieni! Questa ragazza che vedi qui di fronte a te è venuta a trovarmi perché vuole sapere se il suo viaggio in Italia sarà buono e propizio. Io, tua serva, non posso fare nulla ma tu puoi fare tutto, se vuoi. Ogu, Ogu, è la tua serva e padrona che te lo chiede. Io so che solo tu lo puoi fare, perché appartieni a quelli della notte. Noi nella notte vediamo solo ombre. Noi nella notte siamo ciechi. Sei tu che vedi e sai quello che sta succedendo e quello che succederà. Tu vedi e noi siamo nel buio”.
Pronunciate queste parole mi porse un dente di cinghiale. “Lo spirito è qui dentro. Mettiti il dente alla bocca e digli quali sono i tuoi desideri”. Mi portai il dente vicino alle labbra. “Più vicino. Nessuno deve sentire. Solo lui può ascoltare” mi ordinò. Io me lo attaccai sulla bocca e sussurrai, piano piano quanto alimentavo da tempo nel mio cuore. Di andare in Italia, studiare e diventare segretaria. Lavorare in uno di quegli uffici grandi con tante finestre. Avere una scrivania, un telefono e un computer su cui scrivere lettere per il mio capo. Avere un appartamento in città e la sera tornare a casa, magari chissà, trovare un marito che ti rispetta e ti ama e fare figli. Tutto questo bisbigliai al dente. “Ecco ho finito” le dissi restituendole il piccolo oggetto. “Ora salutate”. Madame, che prima di mandarci dalla sacerdotessa ci aveva istruito bene sui gesti e le parole e i loro significati e come avremmo dovuto comportarci, ci aveva avvertito che la frase “ora salutate” voleva dire che avremmo dovuto buttare a terra del denaro: la ricompensa per lo spirito, che la sacerdotessa non avrebbe mai potuto toccare. Quei soldi se li risarebbe venuti a prendere Ogu stesso. Così facemmo. Mio padre gettò il denarosulle pelli di mucca. Lei ci mise in mano sette allillo, piccoli gessetti, che strusciammo fra i palmi fino a farceli diventare candidi. Poi il silenzio calò improvvisamente sull’atmosfera già tesa che aleggiava nel tugurio. All’improvviso Gbedé si alzò, come un automa si mise a cantare e poi girando su se stessa, sembrava una trottola impazzita, avanzò verso di noi. Era come il vento che spalanca una porta, come una scintilla che infiamma il legno secco. Dalla bocca semiaperta della donna uscì una risata strana dal tono maschile. Poi Gbedé parlò: “Ogu ha detto che ti aiuterà, cara Edoway. Ma prima devi portarmi una capra, una gallina, patate, mais, farina, due piccioni e una veste bianca. In più 100 euro”.
Si dice che i doni che pretende il Woodoo non li esige per sé, ma gli servono per ingraziarsi i Ñonli[1]che possono nuocere alla vita dell’individuo per il quale si chiede il favore.
Così io e mio padre tenemmo bene a mente l’elenco di doni che avremmo dovuto portare la volta seguente a Gbedé e ce ne andammo frastornati ma felici di aver ricevuto la risposta che speravamo. Si era avviato un cammino che avevamo intenzione di percorrere fino alla fine: il mio viaggio doveva essere perfetto.
Passarono pochi giorni, giusto il tempo di raccogliere quanto ci era stato richiesto, e carichi come muli ci ripresentammo da Gbedé.
Stavolta l’incontro avvenne di sera e la sacerdotessa mi portò in riva al mare. L’acqua salata e le onde avrebbero pulito i doni e chi li portava e strappato via qualsiasi spirito cattivo.
“Ogu, ti chiamo, la tua serva e padrona Gbedé ti chiama. Tu che hai forza, mentre noi siamo nelle tue mani, metto questo lavoro nelle tue mani: pensaci tu”. Detto questo, Gbedè sputò sette volte dentro una mezza zucca piena d’acqua alla quale aveva aggiunto della cannella, dei chiodi di garofano, dello sciroppo di miele, sette piante officinali e il mais che le avevo portato. Uno dei due piccioni fu soffocato nel liquido melmoso e lasciato dentro la ciotola che mi fu posta sul capo. “Adesso avviati verso il mare”. Camminai lentamente aspettando che la risacca mi sfiorasse i piedi. Poi proseguii arrivando a bagnarmi fino ai polpacci. “Puoi tornare indietro adesso”, mi gridò Gdebé dalla riva. Sempre attenta che la ciotola non mi cadesse, feci il percorso inverso. “Inginocchiati” mi ordinò la sacerdotessa. La quiete attorno si fece strana. Il cielo vellutato sembrava cosparso di una polvere luminosa tante erano le stelle che si mischiavano al profumo del mare. E la luna piena, carica di promesse, stava appesa a guardare, maestosa vestale che tutto conosce e tutto custodisce. Gbedè con un bastone disegnò sulla sabbia umida attorno a me sette cerchi concentrici. Poi prese l’altro piccione e la gallina e con un colpo netto di lama li sgozzò. Tenendo con una mano il piccione ormai morto lo fece girare sette volte sul mio capo sul quale cominciò a colare il sangue caldo del povero animale. Il resto del sangue lo raccolse in un recipiente insieme a quello della gallina. “Bevi un sorso!” mi ordinò. Nonostante lo stomaco aggrovigliato feci anche questo. A quel punto Gbedè iniziò a pregare Ogu. Lo sguardo fisso, la voce vigorosa, a grandi falcate con il passo pesante andò verso il mare e vi buttò tutto quanto era servito al rituale perché il mare se lo portasse via per sempre, insieme agli spiriti cattivi. “Adesso puoi tornare a casa” mi disse. “Dovrai ballare ogni giorno l’akpessè [2] per quattordici giorni. Il quattordicesimo giorno torna da me con una gallina, del mais, igname [3]e sette goro[4] per il rito finale, quello che ti aprirà una volta per tutte la strada buona del viaggio”.
Ballai come mi era stato prescritto. Ogni giorno per quattordici giorni la sera giravo, mi curvavo, ruotavo i fianchi secondo il ritmo della musica trascinante e cantavo a gola spiegata fino a sfinirmi. Mentre mio padre, che tornava dai campi con la zappa e il machete nella sacca di rafia appesa alla spalla, col sudore che gli rigava la fronte polverosa, passava e sorrideva sollevato. Non gli importava se le mani gli facevano male e le gambe erano coperte di terra dopo aver lavorato tutto il giorno sotto il sole. Gli bastava guardarmi e i suoi occhi si riempivano di speranza al pensiero che almeno io presto mi sarei sottratta dalla vita dura che era toccata a lui o da una morte prematura che aveva colpito invece la mamma, che se n’era andata quando avevo appena compiuto cinque anni.
Il quattordicesimo giorno tornai da Gbedé. Stavolta la cerimonia fu molto più breve delle precedenti, ma assai più dura. La sacerdotessa mi fece inginocchiare sulle pelli di mucca della sua stanza. Prese la gallina, la pose sull’altare e la sgozzò. La sventrò sotto i miei occhi inorriditi, le prese il cuore e lo appoggiò su un piatto. “Lo vedi? Dentro questo cuore alberga lo spirito Ogu. Adesso tu lo inghiottirai e Ogu sarà con te per sempre. Guai a trasgredire le sue regole. Sarai la sua umile schiava e ti proteggerà durante il tuo lungo viaggio. Ma se gli disobbedirai egli ti farà del male. Se vorrai scappare dal tuo viaggio egli ti perseguiterà fino alle estreme conseguenze”. Ingoiare quell’organo ancora caldo fu un atto che non dimenticherò mai. Fui costretta ad acchiapparlo solo con la lingua senza l’aiuto delle mani. Dopo vari tentativi andati a vuoto, un po’ per il ribrezzo un po’ per la difficoltà, riuscii a farlo scivolare in bocca e inghiottire. Un urto di vomito violento mi aggrappò lo stomaco e l’esofago. Ma facendo appello a tutte le mie forze fui capace di trattenere il boccone appena ingerito. Gbedè allora mi consegnò un anello dopo averci alitato sopra. “Infilalo. Sarà attraverso di esso che Ogu ti farà sapere se è stato tradito. Il Woodo è capace di andare a cercare qualcuno finanche oltre l’oceano nel paese degli yovo[5], i cui confini sono sorvegliati da altri Woodoo. Questi sono molto potenti sì, danno ai bianchi la padronanza sulle cose che riguardano le macchine, ma non hanno potere sull’anima.
Se disobbedisci a Ogu, il dito comincerà a bruciare, a dolerti così forte da volerlo staccare. Se vuoi scappare dal tuo viaggio o se offendi chi ti ospita, una febbre ti invaderà fino a scuoterti le membra e straziarti. Il Woodoo ti tormenterà il fisico e la mente facendoti dimagrire a vista d’occhio, perché ti estrarrà lentamente tutte le energie. Ma il male potrà riversarsi anche sulla tua famiglia. Attenta dunque a questo anello: sarà lui a rivelarti la grave mancanza. Sarà lui a preannunciarti la inevitabile punizione”.
Me ne andai intimorita e eccitata per la prossima partenza che a quel punto, sapevo, mi avrebbe portato qualcosa di buono. Anche perché non avevo nessuna intenzione di tradire Ogu.
Ma Ogu diventò prestissimo il mio tiranno. Il terrore di un suo fulmineo e implacabile intervento mi dava il buongiorno e la buonanotte. Una volta sbarcata in Italia ero diventata la schiava di tre despoti: Ogu, Madame e Mambo che facevano sì che la paura avesse la meglio sullo schifo della vita che ero stata costretta a condurre. Eppure la ripugnanza che mi prendeva per quello che mi facevano fare ogni notte fino all’alba, molte volte vinse sulla paura. Finché, dopo un anno di notti di nausea, qualcosa di potente mi spinse a cercare una via d’uscita. Angelina forse avrebbe potuto aiutarmi. Era lei che custodiva qualche foglio da dieci euro che abilmente riuscivo a sottrarre dalla somma di denaro che ogni mattina Mambo pretendeva. A Mambo era impossibile sfuggire. Prima di farci ritirare a dormire lui, l’uomo dallo sguardo di fuoco, ci passava al setaccio come molluschi. Ci frugava ovunque per impedire che nascondessimo quanto avevamo tirato su lungo la marina. Ogni dieci giorni poi c’era la cerimonia del pagamento: 300 euro minimo. Se eravamo state brave ed avevamo guadagnato di più, ci prendeva di più. Se non eravamo state capaci di mettere insieme la “rata” pattuita per ripianare il nostro debito con Madame, erano dolori.
Ma qualche foglio da cinque o da dieci riuscivo a salvarlo grazie alla disponibilità di Angelina che, testimone di tanti miei pianti, mi aveva offerto la sua comprensione e un’ancora: se decidi di scappare io ti ospito. Ogni volta che mi aveva fatto la proposta che per me era simile a un barlume di paradiso, l’ombra inesorabile di Ogu si era presentata prepotente a immobilizzarmi. Ma quella volta, più disperata del solito, all’ennesima amichevole offerta di Angelina mi voltai da un’altra parte e accettai. La mattina decisi di non rientrare. Spensi il cellulare e mi accucciai nel divano letto della mia amica in preda a spasmi di paura e di ostinazione a cercare di portare avanti la difficile decisione che avevo preso. Passai una giornata bruttissima. Sapevo di non poter uscire perché temevo di incontrare qualcuna delle mie compagne di strada o addirittura Mambo che, ero sicura, si era già messo sulle mie tracce come un segugio affamato.
La sera accesi il cellulare per verificare quanto temevo. Conteneva diverse chiamate, tutte di Madame e un suo messaggio in segreteria: “Brava Edoway. Brava davvero. Non sei furba. Il tuo debito con me è ancora alto e lo sai. Peccato. Dovrò farlo sapere a tuo padre che sei scappata. Ma glielo comunicherò a modo mio”. Spensi immediatamente il cellulare. Cosa diceva Madame? Non volevo credere a quanto le parole appena ascoltate mi lasciavano immaginare. Naturalmente mio padre era all’oscuro della vita che ero venuta a fare in Italia. Era sempre convinto che studiassi e lavorassi in un supermercato per mantenermi. L’idea che ogni notte lasciassi sulla strada un pezzo di vita e di speranza era inesistente o almeno lontana da lui come la terra dove in quel momento vivevo. “Glielo comunico a modo mio”: questa frase di Madame mi torturò tutta la notte fra incubi e una veglia tormentata in cui mi sembrava di avvertire il dito con l’anello in ebollizione, l’alito fetido di Ogu, fiotti di sangue e bestie mostruose che mi divoravano.
Il giorno seguente, in tarda mattinata riaccesi il cellulare mentre Angelina cercava di calmarmi con un the verde. “Tuo padre non sta bene sai” mi diceva Madame in segreteria. “Ho mandato qualcuno da lui a trovarlo. E mi ha detto che quando se n’è venuto via, tuo padre era a terra, sanguinante, come se lo avessero ammazzato di bastonate”. Lanciai un urlo. In preda al terrore composi il numero di casa di mio padre. Mi rispose Amavi, la vicina che veniva a trovarci di quando in quando portandoci un aiuto domestico, a volte un dono, a volte solo una parola amichevole che però ci faceva bene. “Edoway, è successa una cosa terribile –mi disse piangendo- un uomo, uno sconosciuto, è arrivato ieri sera in casa vostra e ha aggredito tuo padre prendendolo a bastonate. Adesso tuo padre è a letto, l’ho medicato, sta un po’ meglio”. “Passamelo subito” le gridai “ci voglio parlare”. Amavi mi passò mio padre che rispose con una voce flebile e rassicurante “Edoway, non preoccuparti, sto bene”. Non lo lasciai neppure finire. “Papi, che ti hanno fatto? È colpa mia. È colpa mia se ti hanno conciato in quel modo. Tu non puoi capire, tu non sai, ma è tutta colpa mia. Ho paura. Papi, mio adorato papi, aiutami. Voglio venire via da questo posto orrendo”. Era la prima volta che gli parlavo così ma lo smarrimento e il dolore non mi fecero tenere conto del colpo violento che gli stavo infliggendo. “Edoway, ti ripeto, non preoccuparti. Mi dispiace ma tu sei in Italia. Io sono qua. Tu devi estinguere un debito con denaro che io non ho. Non abbiamo scelta. Tieni duro figlia mia. Tieni duro e paga quanto devi. Mi dispiace davvero”. Riattaccò. Mio padre aveva riagganciato il telefono dicendomi quelle parole. Mi sembrava impossibile. Ad Angelina fu necessaria tutta la sua pazienza per tirarmi su dall’incredulità prima, dallo sconforto più nero in cui ero precipitata poi. Ma non bastò. Sentii che c’era una forza, una forza maligna che sembrava imporre al mio destino una sorta di cambiale in bianco: la richiesta era sempre maggiore alle mie possibilità e comunque inevitabile. La sera ero di nuovo da Madame che mi accolse con un mezzo sorriso spavaldo e mi spedì in camera a cambiarmi. Dopo un’ora ero già lungo la marina affogata nel silenzio cupo che segue un’onda d’urto, un uragano, una frana, il crollo di un palazzo.
Così passò un altro anno.
Buio. Due fari accecanti. Buio di nuovo. Quella sera pareva che non si volesse fermare nessuno. E sì che avevo indossato anche la minigonna argentata. Era impossibile non vedermi. Cominciavo a infastidirmi quando vidi un’auto grigia lampeggiare e rallentare davanti a me. Al volante un giovane, sui trenta, dall’apparenza ordinata e pulita. “Vai, stasera è andata bene, meglio del vecchio di ieri” pensai. L’uomo aprì il finestrino della parte del guidatore. “Dai sali” mi invitò in modo un po’ brusco. Era timido. Salii senza farmelo ripetere e lui ingranò subito la marcia e partì. “Andiamo un po’ più avanti, che dici?” Feci il segno di sì con il capo. Musica che non conoscevo, un assolo di chitarra elettrica, invadeva l’abitacolo con note sinistre. Non ci feci caso, certa gente ascolta certa roba… Quando arrivammo alla radura purtroppo familiare –quanti incontri tra quei ligustri- il tizio fermò l’auto. “Scendi. Facciamo due passi” mi disse. Obbedii. Capitava a volte di dover accondiscendere a una specie di preambolo propedeutico, soprattutto con i più giovani. Una passeggiata al buio, due chiacchiere, una sigaretta. E infatti, dopo pochi metri in direzione della spiaggia, la richiesta venne puntuale. Il giovane si frugò nel marsupio che aveva con sé, e poi mi chiese una sigaretta. Gli risposi: “Non fumo. Mi dis..”. Una sberla violentissima partì dalla mano che aveva frugato un attimo prima nel marsupio senza trovare la sigaretta e mi buttò a terra. “Puttana! Maledetta puttana”. Gli occhi sbarrati, la bava alla bocca, quell’uomo mi urlava addosso le peggiori offese. Mi toccai il viso per placare il fuoco che mi bruciava su tutta la guancia destra. Ma mi accorsi che quello che mi era arrivato non era un semplice schiaffo. Mi guardai le mano: era piena di sangue. Il dolore fortissimo, troppo forte in effetti per essere stato provocato da un ceffone, mi fece portare lo sguardo sul pugno stretto con il quale il mostro mi aveva colpito e vidi lampeggiare un bagliore. La lama di un temperino lungo e affilatissimo era lì, ancora in guardia. Mi aveva sfregiato la guancia ed ora era pronta ad attaccare di nuovo.
L’impulso alla fuga fu immediato. Scattai dalla parte del mare e iniziai a correre come una forsennata lungo la spiaggia. La sabbia traditrice era una zavorra alla velocità mentre lui, il mostro, mi incalzava a ruota, pronto ad afferrarmi. Le mie grida di aiuto sembravano sciogliersi nella brezza umida della notte. E lui era sempre più vicino. Il fiato si faceva corto, la corsa disperata sempre più disperata finché misi un piede in fallo e inciampai. Il mostro che era ormai a pochi metri da me non perse l’occasione. Mi afferrò la caviglia bloccandomi. “Ti ho presa, brutta sgualdrina. Ora non mi scappi perché devi morire. Lo sai, sì, che devi morire?”. Piangevo, urlavo, lo supplicavo. “Lasciami ti prego, lasciami andare. Ti dò tutti i soldi che ho”. “Forse non l’hai capito. Non me ne frega nulla dei tuoi soldi. Io voglio la tua testa”. Con un balzo mi fu addosso. Finendo di buttarmi a terra. Ero distesa sulla sabbia, inerme. Lui sopra, che mi bloccava le braccia, in preda a una follia violenta e delirante come una belva che ha sentito odore di sangue. Era finita. Di lì a poco la mia vita sarebbe stata recisa con un colpo di temperino. Ma l’istinto di sopravvivenza riuscì a emergere dal blocco di terrore e darmi l’energia per continuare a gridare: “Aiuto. Aiuto” sapevo che probabilmente era inutile ma era l’unica cosa che potevo fare. “Cosa gridi. Cosa gridi, stupida donna. Non può sentirti nessuno”. A un tratto mollò la presa di un braccio e mi afferrò la gola. Mentre io, con sforzi enormi e vani mi dimenavo come una pantera in trappola, lui iniziò a stringere. “Ti piacerebbe ti strangolassi. Ma sarebbe troppo comodo. Lo vedi questo?” e intanto mi faceva balenare la lama davanti agli occhi inghiottiti dal terrore. “Ora con questo ti sgozzerò. Perché voglio vederti sanguinare e poi voglio vederti morire e poi mi prenderò la tua testa”. Provai a staccare quella morsa d’acciaio dal collo ma lui fu più veloce. Un colpo netto. Avvertii un fiotto di sangue sgorgare dal collo. Poi un rumore forte di freni. Poi più nulla.
Mi risvegliai in un letto d’ospedale. Flebo nelle braccia, tubi, macchinari e strani bip bip. Ero viva. Riordinare gli ultimi ricordi terribili che avevo impressi nella mente non fu impresa facile. Fui aiutata da un’infermiera che, seppi poi, mi aveva assistito per tutto il tempo in cui ero stata in coma nel reparto di rianimazione. Fu lei a riferirmi la ricostruzione della vicenda che mi aveva portata fino a lì. L’aveva appresa dalla polizia. Il mostro che mi aveva assalito era fuggito subito dopo avermi reciso la carotide, spaventato da un’auto che, per un miracolo, aveva deciso di arrivare fino alla spiaggia, e capitare proprio vicino a dove si stava consumando l’aggressione. Era stato il guidatore stesso, vista la scena, a soccorrermi, chiamare l’ambulanza e la polizia. Il maniaco balordo purtroppo non l’avevano preso. Ma io ero stata riacciuffata dalla morte per i capelli. E salvata.
Quanto seguì riguarda un’altra pagina della mia vita. Una pagina bianca e pulita. Che nulla ha che vedere con tutto quello che ho raccontato finora qui. Perché l’inferno esiste sì, ma in terra. E il paradiso anche. Perché l’inferno può prenderti e tenerti avvinghiato. Ma la sete di paradiso alla fine può salvarti.
[1] Spiriti maligni, fatansmi
[2] Ballo tipico della regione che invita all’amore
[3] Tubero dal gusto simile alla patata
[4] Noci di cola
[5] Nel Paese dei bianchi