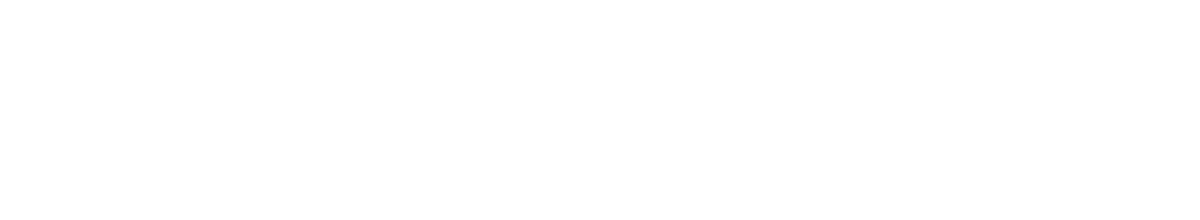L’evoluzione della sanzione punitiva
«Chi percuote un uomo, da farlo morire, sia messo a morte» (Esodo 21, 12)
Il carattere irrinunciabile del principio sanzionatorio, quale strumento di appagamento del sentimento di giustizia dei consociati nei confronti di colui che ha infranto la norma, è riconosciuto da autorevole dottrina (Ponti, 1999), secondo la quale la stessa etimologia del termine «pena» ‑ dal latino poena, che è dal greco poinè, ammenda, indennizzo ma anche castigo, vendetta – di tale principio racchiude l’essenza più profonda e ancestrale. Né la progressiva sublimazione della legge del taglione nel c.d. principio tariffario né l’intento di ridurre l’afflittività della «sofferenza legalmente inflitta» (Ponti, 1999, p. 75), perseguito dai legislatori occidentali a partire dall’Età dei Lumi, pregiudicano la funzione retributiva e satisfattoria della risposta penale[1]. Il carattere afflittivo della pena è ritenuto un’autentica conquista di civiltà (Mantovani, 1984) e la natura ambivalente della punizione, diritto-dovere dell’autorità statale, ne contraddistingue la moderna concezione. Da tempo immemore, essa è «un male […] che colpisce il reo, e lo colpisce in proporzione al mal fatto» (Brasiello, 1982, p. 808).
In epoca remota, la pena assolve ad una funzione esclusivamente vendicativa, legittimando la vittima o i suoi familiari ad infliggere al reo una sofferenza della medesima natura di quella arrecata, secondo la nota simmetria biblica «occhio per occhio, dente per dente[2]». Per secoli, la vendetta rappresenta un diritto immediatamente azionabile dalla vittima o dai suoi congiunti, tanto nel mondo greco quanto in quello romano della monarchia e della prima Repubblica; lo è ancora nel IV-V sec. d.C. e nel diritto germanico (Ponti, 1999). Ne sono un esempio la faida germanica e la vendetta intergentilizia romana, riservate alle offese inter partes e animate dal principio della vendetta privata. Diversa la sorte delle aggressioni al gruppo sanzionate, almeno nel bacino mediterraneo, con il respingimento del reo dalla compagine sociale attraverso la sua eliminazione fisica – tramite sommersione in acqua[3], crocifissione, lapidazione, cremazione – o simbolica, mediante la sua espulsione nelle forme dell’aqua et igni interditio, dell’execratio, della excomunicatio canonica e dell’esilio, cui consegue la morte civile con perdita della cittadinanza e di ogni diritto personale e patrimoniale (Mantovani, 1984).
Al diritto romano arcaico è estranea la funzione vendicativa della pena, essendo la stessa animata da una duplice finalità: quella purificatoria dell’onta, arrecata al gruppo dall’atto illecito, e quella consacratoria alla divinità, offesa dal crimine. In entrambi i casi, si impone il sacrificio del colpevole che, per l’espiazione a scopo purificatorio, deve praticarsi nella forma della crematio, ossia della vivicombustione, mentre per la consacrazione al divino può eseguirsi mediante il supplizio della sospensione all’arbor infelix[4]. Soltanto dopo l’emanazione delle leggi di Silla assumerà rilievo la figura della vittima, alla quale sarà consentito vendicarsi talora uccidendo il colpevole, talaltra cagionandogli un nocumento proporzionato a quello patito. L’evoluzione ‑ successivamente disciplinata dalla legge delle XII Tavole, che legittima l’iniziativa della vittima all’applicazione del talio nei casi di attentato alla persona (Brasiello, 1982) ‑ è innegabile, sebbene la «moderna dosimetria retributiva dei mali» (Mantovani, 1984, p. 404) sia ancora lungi da venire. I segnali prodromici della retribuzione, nella moderna accezione del termine, vanno ravvisati nel rapporto originato dall’atto illecito, che assoggetta il responsabile prima all’iniziativa privata della vittima e, successivamente, ad una riparazione pecuniaria, ragguagliata all’entità del delitto. La punizione, pertanto, deve considerarsi «come un quid da adeguare, ove possibile, al malfatto, e quindi come una retribuzione […]» (Brasiello, 1982, p. 810).
Il crollo dell’Impero Romano d’Occidente segna una battuta d’arresto nell’evoluzione del sistema penale, ora caratterizzato da un’ideologia, propria del mondo germanico, ispirata a criteri opposti rispetto a quelli classici del magistero punitivo pubblico, in cui la pena è inflitta dallo Stato ed è irrogata mediante un processo. È il trionfo della pena privata, rimessa all’arbitrio dell’offeso «in una visione praticamente illimitata dell’azione vendicativa» (Ghisalberti, 1982, p. 813), che contempla, peraltro, la possibilità di composizione della lite attraverso l’offerta di un’adeguata soddisfazione pecuniaria (compositio) per il nocumento arrecato alla vittima. Questo approccio riparatorio non altera, tuttavia, la natura privata della pena, sebbene l’esame delle fonti legittimi interpretazioni diversificate dell’istituto (Diurni, 1982). L’unica sanzione tipicamente pubblica è rappresentata dalla friedlosigkeit o perdita della pace, sia in ragione della natura dell’organo irrogante che delle modalità esecutive della medesima[5]: la sua sopravvivenza nella legislazione longobarda è, però, assai breve, essendole preferite la pena di morte e quella connessa della confisca dei beni.
Nel diritto intermedio, istituti privatistici e pubblicistici ispirati alle consuetudini barbariche convivono agevolmente, nonostante i tentativi dei pubblici poteri di affermare la preminenza dello Stato nell’esercizio della potestà punitiva. Dei riflessi di tale sforzo rimane traccia nell’editto longobardo, che disciplina ex lege il ricorso alla faida e attribuisce alla vendetta privata il carattere di extrema ratio, subordinandone l’esercizio al fallimento del tentativo di composizione. La predominanza della pena privata è riconducibile alla concezione del diritto quale strumento di mantenimento dell’ordine pubblico, la cui violazione è considerata «rottura della pace» e causa di uno stato di inimicizia da rimuoversi attraverso sanzioni pecuniarie comminate nell’interesse esclusivo dell’offeso o del gruppo parentale[6]. La duplice funzione ‑ afflittiva e satisfattoria ‑ della pena garantisce la restaurazione della pace violata, eliminando la condizione di inimicizia conseguente al comportamento illecito. Ciò rende ragione dell’embricarsi di pena privata e di pena pubblica (i.e. criminale) in età altomedievale (Diurni, 1982). Nell’impossibilità di sradicare il ricorso alla vendetta privata – vani i tentativi carolingi, prima e quelli della Chiesa, poi ‑ la successiva legislazione degli Ottoni «finisce per legittimarl(a), cedendo alla realtà della società feudale e trasmettendol(a) in eredità all’epoca nuova che si verrà ad aprire con la rinascita del diritto romano» (Ghisalberti, 1982, p. 814).
Il Basso Medioevo, caratterizzato dalla crescente espansione del sistema feudale, vede lo sviluppo della pena arbitraria (Diurni, 1982), non più subordinata alla previsione normativa come accade nella legislazione longobardo-franca, in cui la discrezionalità nella determinazione della pena è circoscritta all’irrogazione delle sanzioni relative ai crimina pubblica[7] da parte del sovrano. Complice l’inconsistenza del potere centrale, il magistero criminale del feudatario si amplia attraverso la previsione di nuove fattispecie delittuose ‑ soprattutto in materia di attentati alla proprietà e al dominio terriero ‑ e di pene con finalità deterrente, garantita dalla pubblicità dell’esecuzione. All’estensione del magistero punitivo pubblico, esercitato con inaudita violenza nei confronti dei sudditi, il corpo sociale risponde ricorrendo a modalità risolutive dei conflitti parallele rispetto all’intervento dell’autorità, nell’ambito delle quali torna a prevalere l’esercizio della vendetta privata (Diurni, 1982). Incapaci di sopprimere la medesima e le rappresaglie ad essa conseguenti, saranno le nuove realtà comunali a disciplinarne l’esercizio, limitandone la titolarità ai soli parenti prossimi dell’offeso. La prevalenza delle pene corporali rispetto a quelle pecuniarie e il moltiplicarsi delle misure di polizia per contrastare la violazione degli ordini dell’autorità caratterizzano, infine, il sistema penale dell’epoca intermedia.
Nel Rinascimento medievale, alla reintroduzione della pena pubblica ‑ irrogata da un organo statuale su istanza dei pubblici poteri o dei privati interessati ‑ non sono estranei né il rifiorire degli studi romanistici della Scuola di Bologna né il consolidamento degli ordinamenti particolari che ripropongono, sul piano penalistico, gli istituti del diritto giustinianeo. L’irrogazione della pena risponde ora all’esigenza di giustizia e di difesa sociale della comunità e non più alla mera vendetta dell’offeso o dei suoi congiunti, come per l’innanzi. L’apparato sanzionatorio si avvale della pena capitale e delle altre pene corporali e si arricchisce del bando (bannum)[8], di derivazione germanica, unitamente a sanzioni accessorie di natura personale e patrimoniale, derivanti dalla perdita della capacità giuridica ad esso conseguente, quali riduzione in schiavitù, esilio, confisca dei beni e privazione dei diritti civili. L’elusione del principio di proporzionalità è confermata dalla frequente inflizione di pene crudeli, che disconoscono finalità intimidative o emendative del reo, punito in conseguenza della commissione di un delitto e indipendentemente dalla valutazione di qualsiasi funzione utilitaristica della pena. Del resto, lo scarno approfondimento teorico in materia, da parte della dottrina del diritto comune, è ampiamente dimostrato (Ghisalberti, 1982).
Le riflessioni preliminari sul fondamento della potestà punitiva e sullo scopo della pena risalgono ai teologi della Scolastica, che identificano il primo nell’autorità divina – della quale sarebbe investito colui che esercita la potestà medesima, poiché il delitto contrasta con la legge di Dio – e il secondo nel carattere «medicinale» della pena, che consente al reo di espiare la sua colpa davanti all’Onnipotente[9]. È il trionfo della commistione tra crimine e peccato, in una concezione sacrale del diritto penale che si avvale dell’organo giudiziario come braccio secolare della religione e del potere ecclesiastico (Fiandaca & Musco, 1995). All’originaria visione della pena come espiazione del male commesso subentra una prospettiva più articolata della sua finalità individuale e sociale, espressa dal pensiero giusnaturalista della emendatio communis ‑ che della pena richiama il contenuto pedagogico e intimidatorio ‑ o dalla posizione di Thomasius, in cui le funzioni general e specialpreventive, seppure in forma embrionale, si unificano in una concezione globale della pena. Si levano le prime voci contrarie alla pena di morte da parte di giureconsulti quali l’Alciato e il Salmonio mentre scrittori come Tommaso Moro e Campanella, muovendo da premesse ottimistiche sulla natura dell’uomo (Mantovani, 1984), sono tra i primi a schierarsi a favore di interventi sulla criminalità in chiave preventiva. Sul piano teleologico, alla finalità correttiva si affiancano ulteriori connotati, quali la salvaguardia dell’ordine sociale, l’intimidazione e l’esemplarità della pena (Diurni, 1982). Ma è al rinnovato studio del diritto romano giustinianeo che si devono le prime sistematiche elaborazioni teoriche sulla pena, la quale assume progressivamente natura pubblica soppiantando, in maniera definitiva, il sistema delle pene private.
Nel corso dei secoli e con modalità differenti in ragione dello sviluppo dei singoli ordinamenti statuali, il superamento della vendetta privata si realizza mediante privazione o diminuzione di beni individuali quali la vita, attraverso la pena capitale; l’integrità fisica, per mezzo di pene corporali; la libertà personale, con misure restrittive della medesima; l’onore, attraverso le pene infamanti[10] del marchio, della gogna e della pubblicazione della sentenza di condanna; la capacità giuridica, per mezzo delle pene interdittive; il patrimonio, colpito mediante sanzioni pecuniarie. In tal modo, la pena inizia ad assolvere alla duplice funzione di giustizia e di difesa sociale (Mantovani, 1984). In ogni caso, la transizione dalla vendetta alla pena, nella sua accezione attuale e pressoché universalmente accettata, si compie in virtù del principio di proporzionalità, che innalza quest’ultima ad «atto di ragione» in quanto reazione commisurata al male inflitto e non più espressione dell’emotività istintuale ed incontrollata. Proporzionalità «concepita non (già) nei termini meccanicistici della pena vetero-testamentaria del taglione […], ma come concetto etico-sociale, per cui si considera giusto corrispettivo anche un male di diversa natura» (Mantovani, 1984, p. 405), irrogato da un’autorità statuale che interviene a disciplinare casi e modalità di legittimo esercizio del potere sanzionatorio, segnando la nascita del diritto penale quale diritto pubblico (Cantarella, 1991). La finalità vendicativa della pena continua a sopravvivere fino all’epoca moderna sebbene l’autorità avochi a sé, in via esclusiva, l’amministrazione della giustizia. In tal modo, l’esercizio della vendetta viene inibito al singolo per tradursi in prerogativa statale. Solo successivamente all’istanza vendicativa originaria andrà associandosi quella di auto-tutela dell’autorità, nei confronti di atti potenzialmente lesivi dei suoi specifici interessi (Ponti, 1999).
Nella cultura europea pre-illuministica, il reato è un attentato all’autorità del sovrano ‑ la cui persona si identifica con lo Stato (crimen lesae maiestatis) ‑ e il suo autore deve essere punito e materialmente soppresso. Lo strumento punitivo è rappresentato dal pubblico supplizio con finalità deterrente, affinchè ciascuno dei consociati si astenga dal commettere reati. La finalità intimidativa della pena costituisce l’unica modalità di prevenzione generale (Ponti, 1999): l’odierno sistema preventivo diversificato è ancora lungi da venire. L’apparato sanzionatorio vede il largo impiego della pena di morte ‑ anche per reati minori come furto, falso e truffa ‑ e delle pene corporali ad esecuzione pubblica, con modalità particolarmente cruente, quali mutilazioni, fustigazioni, accecamento e abbruciamento[11] (Focault, 1976). «Arbitrio, eccesso, crudeltà ed esasperata spettacolarità» (Fiandaca & Musco, 1995, p. XV) caratterizzano il quadro delle sanzioni punitive: è l’epoca dello «splendore dei supplizi» che, certamente, intimidisce ma esercita anche un fascino seduttivo sul pubblico degli spettatori. Le pene privative della libertà personale sono assai diffuse: alla carcerazione ‑ con durata indeterminata, utilizzata come modalità di attesa del giudizio, per impedire la fuga del reo, oppure come strumento di neutralizzazione extragiudiziale di avversari politici e dissidenti ‑ si affiancano altre misure gravemente afflittive, come la riduzione in schiavitù, la deportazione e la perpetua condanna al remo, oltre a particolari forme di detenzione domiciliare.
Nel secolo XVIII si assiste ad un radicale mutamento degli strumenti punitivi, che confluisce nell’alveo di un più ampio processo di secolarizzazione dello Stato, le cui premesse culturali affondano le radici nella speculazione filosofico-giuridica maturata a partire dal secolo precedente. Il riferimento è d’obbligo a quel movimento di pensiero noto come «giusnaturalismo laico», che supera le concezioni teocratiche allora dominanti ancorando la legittimazione delle istituzioni statali a un diritto naturale laico e terreno, fondato sui princìpi di ragione. Grozio per primo teorizzerà la necessità di bandire la confusione tra delitto e peccato, sottolineando l’autonomia delle rispettive sfere del diritto e della morale (Fiandaca & Musco, 1995). È ai teorici del giusnaturalismo che si deve il superamento del carattere meramente vendicativo-intimidativo della pena in favore di finalità rispondenti a criteri di equità e di giustizia, aprendo la via all’affermazione delle concezioni utilitaristiche e umanitarie che domineranno il panorama giuridico dei secoli a venire (Diurni, 1982). Il processo di modernizzazione del diritto penale trova compimento nell’ambito del pensiero illuministico, che combatte l’arbitrio giudiziario, mitiga le sanzioni punitive evitando ingiustificati eccessi di sofferenza ai condannati, razionalizza il sistema dei delitti e delle pene allo scopo di renderlo un efficace strumento di prevenzione dei reati (Fiandaca & Musco, 1995). La tortura e le pene corporali vengono progressivamente abbandonate, si riducono le ipotesi per le quali è comminabile la pena di morte mentre la detenzione in carcere assurge a strumento punitivo elitario.
L’ideologia penale liberale, magistralmente descritta dal Beccaria nella sua opera più celebre del 1764, tratteggia le caratteristiche salienti della sanzione punitiva: dal significato retributivo, non solo vendicativo e intimidatorio; proporzionata alla gravità del delitto; mitigata nella sua severità, con esclusione delle pene afflittive e abolizione della pena capitale. Sorge, così, l’istituzione carceraria nella moderna accezione del termine, con la costruzione di stabilimenti penitenziari deputati alla reclusione, in sostituzione delle fortezze militari precedentemente utilizzate come luogo di detenzione (Ponti, 1999). È il passaggio dal pubblico supplizio dell’epoca preilluministica al carcere, strumento punitivo solitario e segreto[12], che risponde all’organizzazione dell’attività umana secondo il principio della disciplina: la stessa che rende gli individui docili e funzionali al modello produttivo settecentesco (Foucault, 1976). «Il carcere è l’emblema del modello di organizzazione del potere disciplinare, esercitato come strumento di dominio dal Potere, il quale esclude dalla vita sociale coloro (delinquenti, pazzi ecc.) che possono mettere in discussione il rapporto di disciplina che lega i cittadini allo Stato, per sottoporli alla disciplina carceraria che rieduca alla più generale disciplina» (Mantovani, 1984, p. 227). Così definito, il ruolo punitivo del carcere predominerà almeno fino alla metà del XX secolo (Ponti, 1999).
I tempi sono maturi per il superamento della concezione vendicativa-intimidativa della pena e, coerentemente con gli ideali etici e filosofici sette-ottocenteschi, prende corpo il principio della retribuzione ‑ dal latino retribuo, do il dovuto ‑ quale finalità primaria della sanzione punitiva: il richiamo al principio di proporzionalità tra entità della sofferenza inflitta e gravità del delitto consumato diviene, ora, esplicito e necessario. Kant riconosce, nel principio retributivo, la sola misura certa della qualità e della quantità della pena, in maniera conforme ad una concezione ancora oggi dominante nella prassi penalistica tedesca (Klug, 1989). Anche secondo Hegel la pena è retribuzione e, precisamente, lesione della lesione[13]. Si riaffaccia il significato della punizione come emenda ‑ mezzo di riabilitazione spirituale del reo attraverso la presa di coscienza della propria colpa ‑ e il carcere diviene strumento di punizione ma anche di autocorrezione (Ponti, 1999), con l’impiego delle modalità trattamentali che si reputano necessarie a correggere moralmente il condannato, modificandone il futuro comportamento: disciplina rigorosa e regolamenti afflittivi, lavoro coatto, obbligo delle pratiche religiose e del silenzio, squallore degli ambienti, povertà dell’alimentazione, isolamento dal mondo esterno e dagli altri reclusi. La concezione etico-retributiva della pena postula il libero arbitrio nella scelta delle proprie azioni, introducendo il concetto della responsabilità morale quale fondamento della rimproverabilità del male commesso. Volontà colpevole, imputabilità e retribuzione saranno, infatti, i capisaldi della Scuola Classica, maturata nell’ambiente politico-culturale illuminista e tesa ad opporre i presupposti razionali della punibilità agli eccessi e alle crudeltà dell’epoca (Mantovani, 1984). All’indomani della Rivoluzione francese, l’adeguamento della struttura giuridico-normativa ai princìpi liberali dell’Illuminismo trova compimento nel Code Napoléon del 1804, cui si ispireranno l’intera codificazione europea e quella sudamericana dell’epoca (Ponti, 1999). È in tale contesto che nascono le dettagliate articolazioni giuridiche del c.d. sistema tariffario, fondato sulla minuziosa previsione codicistica delle differenti fattispecie delittuose e sulla calibrata commisurazione della pena in ragione della diversa gravità delle medesime, al fine di garantire parità di trattamento a tutti i consociati.