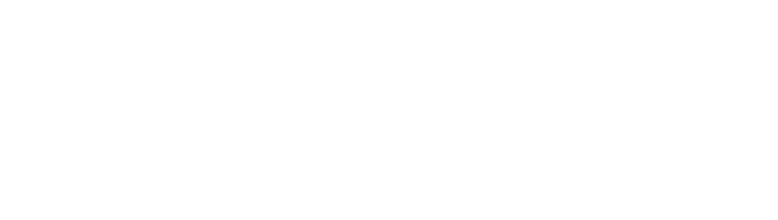Identificazione forense e dattiloscopia
Per ragioni storiche e sociali, che faticano ad essere superate, l’indagine processuale si è sempre interessata poco alle vittime, concentrandosi più che altro sull’autore e sul fatto criminale. Le motivazioni di questo ritardo sono molteplici; discorsi e riflessioni come “Giustizia riparativa” e “mediazione in ambito penale”, stentano, non poco, ad affermarsi.
Anche nell’ambito della Diritto penale e processuale il reato è tradizionalmente inteso come un evento ai danni dello Stato, mentre alla vittima è attribuito un ruolo passivo: “l’offeso”, “la persona offesa”, “la parte lesa”, “la persona offesa dal reato”.
Solo di recente il ruolo centrale della vittima di reato ha cominciato ad essere compreso dalle Istituzioni quale parte integrante del più vasto discorso criminologico; questo anche nell’ambito delle indagini tecnico-scientifiche che in questo senso possono “dar voce” a chi non può o non vuole parlare.
Identificare un pericolo risponde a un bisogno primario di protezione e sicurezza. È un meccanismo in parte istintivo, legato alla legge primordiale di auto-conservazione, che impone il riconoscimento del pericolo e la reazione ad esso, e in larga misura appreso.
Distinguere l’autore di un crimine ha un significato per molti versi analogo.
Serve, da un lato, a preservare l’individuo (e quindi la comunità) da un rischio, dall’altro, è un processo culturale e valoriale mediato da rappresentazioni simboliche mutate nel tempo. Non va dimenticato che lo studio sistemico e “multi-causale” del crimine, inteso come comportamento tipico della specie umana e fatto sociale, costituisce uno sviluppo relativamente recente. Così come è recente l’idea di ricercare entro sfere di normalità l’agire deviante e i complessi rapporti fra persona, comportamento, organizzazione giuridico-sociale dell’ambiente.
L’ambito di applicazione delle indagini scientifiche e la loro maturazione è un tema piuttosto recente per la cultura investigativa italiana. Fino a non molti anni addietro esistevano delle ragioni profondamente radicate nel tessuto del Paese, che hanno di fatto ostacolato una piena consapevolezza rispetto all’idea di verità giudiziale. Oggi sono ancora molto forti taluni pregiudizi e falsi miti che rendono difficile l’accettazione della scienza come strumento, quanto più possibile imparziale, al servizio della verità.
Un aspetto non secondario per comprendere la genesi dei sistemi d’identificazione giudiziaria “ante scientia” è quello della sovrapposizione, che ci fu per molti secoli, tra mezzi d’indagine, strumenti di riconoscimento del reo, misure punitive, miti, superstizioni, riti.
In passato, la giustizia non aveva strumenti per agire scientificamente e quindi qualunque mezzo, anche con valenza etica nulla, fu adoperato, in assenza di scelte razionali praticabili. Alcuni tentativi empirici per identificare il reo quale contenitore delle cause del crimine, dotato di «irregolarità fisiche o stimmate che si fondano sulla diffusa credenza popolare secondo cui delinquenti si nasce» (Balloni, 1986, 29), risalgono assai indietro nel pensiero umano e hanno avuto più influenza di altri.
Per quasi tutta la loro storia più antica, l’identificazione e l’indagine per fini di giustizia, furono caratterizzate esclusivamente dalla commistione tra reato e peccato e da metodi empirici, rudimentali, approssimativi, barbari: testimonianze oculari spesso inattendibili; ordalie, processi sommari, supplizi corporali o psicologici nei confronti dei rei e dei testimoni; delazioni e denuncie segrete, di frequente corrotte da idee religiose, politiche, da miti e superstizioni. Se in passato torture e mutilazioni erano le pene previste per talune tipologie di delitto, contemporaneamente esse finirono anche col corrispondere, nella brutalità dei loro esiti, ai primi sistemi di riconoscimento del recidivo.
Per semplificare: laddove il furto era punito con la pratica diffusa dell’amputazione della mano (oppure delle dita per il reato di entità più lieve) e l’allontanamento dalla comunità, il criminale diventava facilmente individuabile nella nuova comunità di approdo. Era addirittura possibile stabilire se aveva sottratto (o cercato di sottrarre) oggetti di valore o di poco conto. Inoltre, il supplizio era spesso pubblico proprio per etichettare il condannato, renderlo riconoscibile, e per farne un esempio da cui sottrarsi.
Analogo discorso vale per la tortura come mezzo per estorcere la confessione. La marchiatura a fuoco, che nacque come strumento punitivo per i reati meno importanti e come mezzo d’interrogatorio, finì col diventare anche un contrassegno di riconoscimento che rendeva palese l’abitudine al delitto. Per un lungo periodo questa pena fu molto comune specie in Inghilterra (Riley Scott, 2008, 184).
Solitamente il ferro rovente era applicato sul dorso della mano sinistra, su una spalla o sul volto:
«I vagabondi venivano marchiati con la lettera R (rogues), i ladri con la lettera T (thief), per gli spergiuri, una parte della pena consisteva nella marchiatura della tempia con la lettera P (perjuerer) […] In Francia, tutti i reati minori venivano puniti attraverso la marchiatura con il fleur de lis […]» (ibidem, 2008, 184).
L’identificazione forense nell’accezione moderna
Tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, si innescò un processo culturale, economico e sociale che trasformò il modo di vivere, lavorare, abitare, delinquere. Il bisogno di sicurezza mutò di prospettiva quando la popolazione demografica mondiale aumentò in modo esponenziale e il comportamento umano cambiò soprattutto a causa dell’ambiente sociale.
Il riconoscimento dell’altro per fini di giustizia divenne un fatto via via più problematico e incerto quando numerose persone, anonime e mobili, di differenti culture, cominciarono a coabitare. Questo fenomeno, relativamente recente, iniziò con la Prima Rivoluzione Industriale.
Va detto, che prima della modernità, il ricorso da parte dei cittadini alla giustizia istituzionale era una prassi tutt’altro che consolidata. Il controllo sociale era prevalentemente di tipo indiretto e informale, erano gli stessi abitanti della comunità ad auto-regolarsi e a esercitare un controllo reciproco e costante. Nei registri della giustizia francesi del XVI secolo, viene spesso riportata la dicitura «preso dal vicino oppure colto in flagrante dai vicini» (Loubet Del Bayle, 2008, 32).
Ancora oggi nelle comunità tribali, fondate sulla solidarietà meccanica, il controllo sociale è quasi esclusivamente di tipo spontaneo e informale. Il riconoscimento è un processo automatico, grazie anche alla comunicazione orale faccia a faccia, che pone le persone continuamente a confronto le une con le altre. Al loro interno ogni membro ha una cognizione profonda dell’alterità ed è in grado di identificarla: «Il controllo è diretto e immediato perché l’universo sociale è ristretto e tutti i membri si conoscono» (ibidem, 27). Il deviante è facilmente riconoscibile laddove i vincoli sociali tra le persone sono molto coesi. Nella comunità «che vive ripiegata su se stessa» (ibidem, 27), diventa quasi impossibile dissimulare comportamenti e gesti e sfuggire al mutuo controllo e la devianza è contenuta entro confini prevedibili. Non a caso le prime categorie soggette al controllo di polizia furono le «popolazioni non fisse, socialmente mal integrate, fuori dei controlli comunitari informali: soldati disertori, nomadi, vagabondi, mendicanti, stranieri, ambulanti, lavoratori stagionali […]» (ibidem, 33).
Fu solo con lo sviluppo societario e scientifico in seno alla modernità e col passaggio da comunità d’individui, a società complesse, differenziate e organiche, che si avvertì l’urgenza di re-interpretare il bisogno di sicurezza e i meccanismi che lo regolavano. Le prime prospettive scientifiche di identificazione forense, intuitive e pratiche, emersero solo dalla seconda metà dell’Ottocento in un periodo di risveglio della criminologia, e «decisivo fu il ricorso alla scienza per comprendere il mondo» (Giddens, 2006, 17). Nacquero e si svilupparono di pari passo con le più recenti teorie criminologiche dell’epoca. Teorie di cui l’opera L’uomo delinquente di Cesare Lombroso è forse la più significativa sintesi di pensiero. Certo la più nota. Dalla seconda metà dell’Ottocento aveva preso forma l’idea, non nuova, che la tendenza a delinquere avesse un’origine biologica, che poteva essere individuata attraverso la misurazione di alcune variabili, derivabili da caratteristiche fisiologiche o comportamentali. L’approccio biologico al crimine, insieme alle teorie darwiniane sull’ereditarietà, furono gli iniziali tentativi scientifici di dare ad esso una spiegazione plausibile e soprattutto quantificabile. Col determinismo di Lombroso nacque la moderna criminologia. In particolare, la statistica, la medicina, e la biologia positivista, furono impiegate per elaborare alternative all’impianto illuministico: anziché insistere sulla libera intenzionalità della scelta delinquenziale, si identificarono le tendenze criminali in difetti individuali.
Ai discorsi della Scuola Positiva s’ispirarono tre indicativi autori che possono essere considerati gli antesignani dei primi “investigatori forensi”: Alphonse Bertillon, iniziale curatore del segnalamento giudiziario antropometrico; Salvatore Ottolenghi, l’inventore del sopralluogo di polizia giudiziaria; Francis Galton, l’ideatore della dattiloscopia, o studio forense delle impronte papillari. Ancora oggi quelle scoperte conservano un evidente valore scientifico, anche se le premesse epistemologiche da cui scaturirono, ovverosia la natura atavica e la tara biologica del delinquente nato, pietre angolari su cui poggiava l’edificio positivista, si sono rivelate inesatte.
Gli epigoni dell’identificazione forense dei criminali furono dunque scienziati positivisti. Per lo più medici, biologi, genetisti o studiosi di statistica e antropometria, che si sforzarono di osservare, ordinare, fissare e classificare il comportamento criminale attraverso l’uso dei più moderni ritrovati scientifici: dagherrotipo, dattiloscopia, segnalamento antropometrico. Elemento distintivo comune tra essi, fu il ricorso a tecniche di ricerca proprie del procedimento scientifico galileiano e confluite nelle scienze sociali grazie al Corso di filosofia positiva di Auguste Comte che «Ambiva a creare una scienza della società in grado di spiegare le leggi del modo sociale così come le scienze della natura spiegavano il mondo fisico» (Giddens, 2006, 18).
Il primo metodo scientifico d’identificazione biometrico, detto bertillonage, fu sviluppato nel gabinetto di segnalamento del carcere di Parigi. Il procedimento di Bertillon, noto anche come “ritratto parlato”, pensato e applicato per fini identificativi dall’anno 1880, fu ufficialmente pubblicato per la prima volta nel saggio Une application pratique de l’anthropometrie, Extrait des Annales de Dêmographie Interne (1881). Si basava sulla misurazione, classifica e comparazione di undici segmenti del corpo, corredati dalla descrizione di caratteristiche fisiche e di contrassegni, particolarità fisiche rare, riproduzioni fotografiche e anche rilievi dattiloscopici che tuttavia non furono, in quella circostanza, utilizzati per scopi identificativi. Secondo i calcoli statistici di Bertillon, la probabilità che una particolare misurazione fosse esattamente la stessa per due individui differenti era di 1/4. Le possibilità che due persone differenti possedessero, ad esempio, stessa altezza e la stessa circonferenza cranica, sarebbe stata quindi di (1/4)2, e così via. La probabilità che due persone diverse avessero in comune tutte e undici le misure era di (1/4)11, ovverosia una su 4.191.304.
La tecnica del bertillonage, pur rivelandosi molto macchinosa, anche a causa dell’inadeguato numero di poliziotti rispetto a quello degli arrestati presenti nel territorio di Parigi, fu impiegata in larga scala dal 1883 in tre differenti gabinetti di segnalamento: la citata Surete di Parigi e presso le prefetture di Lyon e Marsiglia e rimase ufficialmente in vigore sino al 1914. Oltre all’evidente complessità di esecuzione pratica, quel procedimento di identificazione forense aveva altri due limiti. Il primo era rappresentato dal fatto che lo scheletro umano muta nell’arco della vita. Il secondo era che la “classifica” di persone con caratteristiche fisiche simili finiva spesso col coincidere e col sovrapporsi, dunque, in assenza di altri contrassegni salienti, era molto difficile, per non dire impossibile, attribuire un’identità certa alla persona. D’altra parte quello di “uomo medio” era un principio già acclarato all’epoca in cui scrisse Bertillon, soprattutto grazie alla “La physique sociale” (1835) di Adolphe Quetelet, e agli studi statistici della Scuola Cartografica. E fu proprio quest’ultimo limite, insieme alla scoperta dei metodi di classifica dattiloscopici, a decretare la fine del bertillonage come sistema di identificazione.
“Finger Print” e “Finger Print Directory”
I testi di Francis Galton, Finger Prints, pubblicato nel 1892, e Finger Prints Directory, di tre anni successivo, furono gli “atti fondanti” della dattiloscopia e rimangono tutt’oggi i saggi di riferimento per chi si occupa di questa disciplina. Anche i più complessi studi successivi, ad esempio: Finger Prints, Palms and Soles An Introduction To Dermatoglyphics di Cummins e Midlo, del 1943, considerato una sorta di “Bibbia” dei dermatoglifi, soprattutto per quanto attiene lo studio dell’embriologia e della genetica, convalidarono molte delle intuizioni attribuite a Galton.
La dattiloscopia entrò molto velocemente nella realtà della criminologia, trovando un terreno particolarmente fertile all’interno della società imperialistica vittoriana del XIX secolo. Fu applicata, da subito e in maniera imponente, nelle colonie britanniche dell’East India Company e nelle vaste comunità carcerarie del Regno Unito.
La questione su “come”, “quando” e “da chi”, essa sia stata impiegata per la prima volta, per scopi forensi, è una faccenda non scevra da certe ambiguità. Varie fonti accreditano la scoperta a un medico scozzese: Henry Foulds, che nell’ottobre del 1880, dodici anni prima di Galton, la illustrò sulla rivista scientifica Nature, con un articolo dal titolo “On the Skin-furrow of the Hand”:
«Quando si trova un’impronta digitale insanguinata o impressionata nella creta o sul vetro, & c., essa può condurre all’identificazione scientifica di criminali. Già io ho avuto l’esperienza in due casi, trovando la corrispondenza effettiva di questi segni. In una circostanza l’impronta digitale rivelò chi aveva bevuto da un bicchiere» (Foulds, 1880, 605).
Vi è anche un secondo termine di raffronto che avvalorerebbe questa ipotesi. Foulds intrattenne con Charles Darwin, cugino di Galton, un rapporto epistolare grazie al quale, quest’ultimo, venne a conoscenza di alcune informazioni, forse appropriandosene. Tuttavia, Foulds, che probabilmente riuscì anche ad individuare l’autore di un furto grazie a un’impronta digitale, probabilmente, cadde nell’equivoco di sottovalutare il potenziale della dattiloscopia come disciplina forense, volendo insistere soprattutto sull’opportunità di stabilire, attraverso essa, alcune regole generali sull’ereditarietà e sulle possibili differenze razziali tra le popolazioni. Concentrò gran parte dei suoi studi in quella direzione, seguendo un orientamento particolarmente caro agli studiosi positivisti e basato sui principi della genetica mendeliana e del darwinismo sociale.
Al di là dalle mere speculazioni, giova rilevare che Galton, grazie anche al contributo di William Hershel, ufficiale del Servizio Civile Indiano britannico nel distretto Hooghly in Jungipoor in India, produsse un’opera che potremmo, senza rischio, definire completa, poiché riuscì a indagare discorsi e riflessioni che non si ritrovano in alcuno degli autori che l’hanno preceduto: approfonditi studi su sistemi di classifica e codifica delle impronte, calcoli statistici sulla loro variabilità, metodi di assunzione e di rilevamento delle impronte attraverso l’uso dell’inchiostro tipografico, utilizzo di strumenti di catalogazione e archiviazione; ma fu soprattutto grazie a Galton e alla sua collaborazione con Edward Henry, “Commissioner” della Metropolitan Police di Londra tra il 1903 e il 1918, che le Corti britanniche prima, e quelle di tutto il mondo successivamente, conferirono alla dattiloscopia la valenza probatoria che ancora le spetta. Edward Henry, col saggio Classification and uses of fingerprints (1900), fu anche il realizzatore del primo metodo di classifica decadattilare “istituzionalizzato”, ufficialmente accolto dall’“Home Office”, il Ministero per gli Affari Interni del Regno Unito.
Conviene anticipare le due premesse di base su cui si basa la dattiloscopia: la persistenza della morfologia dell’impronta nell’arco della vita e l’individualità. Mentre la prima premessa richiama un dato in gran parte intuitivo, stabilito poi con assoluta certezza dagli studi sull’anatomia e sulla morfogenesi delle creste papillari, l’individualità o identità assoluta è soggetta ad una verità empirica sostenuta da un fondamento statistico. L’individualità dattiloscopica, al pari dell’unicità della persona umana, esiste solo in senso retorico; è un assioma. Ognuno ne comprende l’esattezza ma rimane un dato impossibile da dimostrare. Con un’unica eccezione. Quella del fatto concreto che porta all’individuazione in casi giudiziari specifici. La dattiloscopia si fonda su criteri di certezza assoluta perché equipara la nozione di “rarità” con quella di “unicità”. La complessità e la delicatezza dell’argomento erano state rilevate già dalla fine dell’Ottocento da Galton stesso: «Il nostro problema è questo: date due impronte digitali simili, quale è la probabilità che appartengano a persone diverse?» (Galton, 1892, 100).
Finger Prints è un volume di tredici capitoli. Se si escludono i numeri undici e dodici, centrati in gran parte sull’improbabile tentativo di stabilire connessioni tra forma delle impronte papillari, ereditarietà e razza, molti passaggi dell’opera rilevano, a più riprese, quelli che possono essere considerati i tre precetti in capo alla dattiloscopia:
- immutabilità delle impronte nell’arco della vita, per cui «non subiscono variazioni morfologiche naturali» (Donato, 2006, 52);
- varietà e differenza delle forme papillari nel singolo individuo e nella popolazione: «non è possibile ritrovare una stessa impronta, sia pure parzialmente riprodotta, in più persone […] o nello stesso individuo» (ibidem, 52);
- opportunità di codificare le impronte digitali «che pur nella loro infinita variabilità possono essere catalogate sulla base delle loro caratteristiche generali» (ibidem, 52), da cui la possibilità di classificare e archiviare il dato.
Dall’ultima tesi nacque la tripartizione di Galton per cui le impronte digitali sono sempre riconducibili a tre forme: arch (arco o adelta), loop (ansa o monodelta), whorl (spirale o bidelta), grazie alla differente curvatura delle linee papillari:
«Per chi studia l’impronta digitale, i primi oggetti da guardare sono i delta [1], accertare se il modello ne possieda due, uno o nessuno […] La caratteristica principale degli archi è l’assenza di delta; un cappio ne ha uno; una spira ne ha due […] Ci sono alcuni modelli ambigui, ed altri che sono indefiniti, ma i primi sono non comuni ed i secondi rari; a parte queste eccezioni, esistono pochi inconvenienti, la classificazione funziona facilmente e bene» (Galton, 1895, 62, 78).
La prima caratteristica evidente è che qualsiasi impronta digitale risulta costituita da fasci di linee ben determinati. Galton indicò in un numero di tre questi fasci:
- quello basale, costituito da linee situate alla base del polpastrello, più precisamente tra la II falange e l’inizio della III falange, in corrispondenza dell’articolazione;
- quello marginale, presente all’apice della III falange e che decorre lateralmente rispetto ad essa, circoscrivendo il polpastrello esternamente;
- quello centrale, in corrispondenza appunto della zona epicentrale della terza falange e che include il c.d. centro di figura, che può assumere configurazioni diverse. «I sistemi di linee nelle loro evoluzioni formano anche delle zone definite delta o triradi, che costituiscono delle aree di adiacenza dove i sistemi basale, marginale e centrale confluiscono.» (Intini-Picozzi, 2009, 316).
La possibilità d’individuare quei sistemi di linee fu anche la premessa indispensabile che permise di “classificare” le impronte digitali a partire dal 1900. Inizialmente i sistemi di classifica delle impronte digitali consistettero essenzialmente nell’individuare alcune forme e attribuire ad esse un codice alfanumerico o numerico.
Questo semplice passo consentì di restringere notevolmente i margini di ricerca dei potenziali recidivi, ovverosia già sottoposti ai rilievi dattiloscopici, riducendo lo sforzo necessario, in quanto la ricerca si orientava esclusivamente su una precisa sequenza numerica (si tenga conto che una classifica decadattilare può avere anche dieci miliardi di combinazioni differenti).
Galton comprese anche che i disegni delle creste papillari erano immutabili nel tempo. Lo fece grazie ad un esperimento, strumento di indagine molto diffuso all’epoca. Rilevò e poi analizzò, in due occasioni, diversi campioni di impronte assunti su alcuni bambini e poi li confrontò a distanza di anni verificando l’assoluta corrispondenza delle impronte. Egli considerò, con giusta causa, anche il fatto che il dermatoglifo si forma nell’ambiente intrauterino prima della nascita:
«Lo sviluppo embriologico delle creste papillari è stato studiato da molti, ma specialmente dal Dott. A. Kollmann’, […] Egli ha stabilito che le creste si formano attraverso pressioni laterali delle strutture embrionali […] Si dice che le creste siano discernibili nel quarto mese della vita fetale prima, per formarsi pienamente entro il sesto […]» (Galton, 1892, 58-60).
Queste e altre osservazioni, diedero facoltà di formulare una teoria generale e di chiarire soddisfacentemente il problema che nessuna ipotesi precedente aveva consentito di interpretare: l’opportunità di identificare, con nessuna possibilità di errore (purché sussista un minimum di caratteri), la persona.
Insieme a queste peculiarità, Galton ne indicò una ulteriore, la c.d. “morfologia particolare” dell’impronta. Nelle creste papillari sono infatti presenti alcune accidentalità o imperfezioni, che si è soliti nominare in relazione alla forma che assumono (biforcazioni. interruzioni, tratti di linea, occhielli, uncini, isolotti, punti); le discontinuità delle creste papillari sono chiamate minuzie, punti caratteristici, o “Galton’s dectail”, queste accidentalità sono molto significative e rendono unica l’impronta (Ceccaroli, 2000, 140 e ss.).
Nell’epidermide, lo strato più esterno della cute, in corrispondenza dei polpastrelli delle dita, del palmo della mano, della pianta del piede, sono incluse le c.d. “creste cutanee o papillari” o dermatoglifi; queste hanno uno spessore variabile e formano disegni assolutamente originali.
Ciò è dovuto al fatto che le impronte possiedono segni generali (andamento delle linee delle creste cutanee) e soprattutto particolari (le c.d. minuzie); sono questi ultimi che rendono unica la morfologia complessiva dell’impronta: «Queste caratteristiche morfologiche delle impronte papillari sono considerate elementi particolari e su di esse si fonda l’intero apparato dell’identificazione dattiloscopica.» (Intini-Picozzi, 2009, 315).
La superficie cutanea digitale, palmare e plantare, non è quindi liscia, ma presenta molte irregolarità sotto forma di solchi più o meno profondi, creste, pieghe, depressioni.
Il disegno delle creste e dei solchi, è definito geneticamente a partire dalla tredicesima settimana dopo il concepimento, per formarsi definitivamente intorno alla ventunesima; di conseguenza saranno invariabili anche i disegni che esso forma sulla superficie cutanea e rimane tale fino al sopraggiungere dei fenomeni tanatologici. Tali creste hanno uno spessore dell’ordine della frazione di millimetro; la loro funzione è permettere lo sviluppo dell’attrito e quindi l’attività prensile tipica dei primati.
L’impronta è quindi il segno lasciato dalle creste epidermiche delle papille, separate tra loro da solchi, e sulla cui sommità si aprono i pori sudoripari.
Attualmente le polizie di tutti i Paesi adottano sistemi biometrici per l’identificazione dattiloscopica. In Italia, il sistema A.P.F.I.S. (Automated Palmars and Fingerprints Identification System) utilizza un algoritmo della Cogent System. APFIS è un software in grado di archiviare, codificare e confrontare con procedure in parte automatizzate, in tempi molto rapidi, le milioni di impronte digitali e palmari presenti nei database del Casellario Centrale di identità presso il Viminale.
Dattiloscopia e orientamento giuridico
La prima definizione “potenzialmente scientifica” di unicità in ambito forense, nacque nel 1835 col belga Adolphe Quetelet, che insieme a Andrè Guerry fondò la statistica descrittiva sociale.
Quetelet cercò di spiegare il comportamento umano attraverso la probabilità statistica del verificarsi di certi eventi umani, partendo dall’esistenza di un presunto “uomo medio”. Ipotizzò, come altri prima di lui, che mai la natura si ripete e che moltiplicando tra loro le probabilità che eventi umani tra loro indipendenti, ciascuno dei quali in grado di assumere valori differenti, la possibilità ultima di ottenere due valori assolutamente identici è un limite che tende allo zero.
In altre parole la probabilità, espressa in termini matematici, che un evento possa verificarsi è un numero compreso tra “0” e “1”; dove la cifra “1” rappresenta l’identità assoluta accertata e “0” il suo opposto.
L’esempio classico è quello del dado da gioco. Se si lancia un solo dado la probabilità di ottenere un numero prestabilito è rappresentata dalla frazione 1/6. Se si lanciano diciassette dadi, la probabilità statistica di ottenere una sequenza di numeri prestabilita è “1/6“che moltiplica “1/6“ per diciassette volte: (1/6)17.
Questo principio fondamentale della statistica è detto “regola del prodotto” ed è estendibile ad eventi indipendenti tra loro, anche, ad esempio alla distribuzione delle minuzie in un’impronta.
Il metodo statistico di Victor Balthazard, ad esempio, lo stesso accettato e riconosciuto dalla Corte di Cassazione italiana, muove dall’ipotesi che un’impronta “completa” possieda circa cento punti caratteristici; la rarità (e non unicità) è così espressa dalla formula: (1/4)n, dove la cifra “quattro”, rappresenta il tipo di minuzie che si ritrovano con più frequenza in un’impronta (termine di linea e biforcazione verso destra e verso sinistra), mentre “n” rappresenta il numero di minuzie uguali per forma e posizione. Ad esempio, se a “n” si attribuisce il numero 17, si ottiene: (1/4)17 = 1/ 17.179.869.184. Che in altre parole significa: una possibilità su diciassette miliardi che due impronte con diciassette punti in comune, uguali per forma e posizione, appartengano a due persone differenti.
Come già anticipato, l’assioma aristotelico dell’identità assoluta, per cui ognuno è uguale solo a se stesso in un limite di spazio e di tempo, è un principio intuitivo e ovvio ma indimostrabile. La probabilità statistica di trovarsi di fronte a due impronte, o parti di esse, con un certo numero di punti caratteristici in comune, uguali per forma e posizione, appartenenti a persone diverse, è un limite che tende a zero. Tuttavia, la popolazione umana è formata hic et nunc da oltre sei miliardi d’individui cui è possibile associare più di dodici miliardi di impronte di mani e sessanta miliardi di impronte digitali. Questo dato è anche in continuo aumento se si considera che la popolazione mondiale è destinata, almeno nelle previsioni più reali, ad aumentare in modo esponenziale.
Un altro ordine di problemi deriva dal fisiologico margine di errore che contraddistingue qualsiasi procedura scientifica, anche la più rigorosa; cioè la possibilità di ottenere i c.d. “falsi negativi” o “falsi positivi”. A quest’ultima si deve aggiungere, infine, l’ipotesi della contraffazione volontaria e dolosa di prove. Se falsificare una testimonianza resa in giudizio è un fatto tutt’altro che impossibile, non di meno, manipolare una prova scientifica è più complesso ma non certo irrealizzabile.
In tutto il mondo, l’identità attraverso l’impiego delle impronte papillari ricopre un ruolo preminente e indiscusso nell’indagine forense. Sono principalmente tre gli ambiti di applicazione dell’identità dattiloscopica.
Il primo attiene, come anticipato, la c.d. “dattiloscopia giudiziaria”, ovverosia la possibilità che le tracce papillari trovate sulla scena del crimine, portino alla ricostruzione di fatti delittuosi. In altre parole si concretizza con la possibilità di individuare le persone che, a vario titolo, erano presenti sul luogo in cui si è consumato un reato.
Una seconda serie di prescrizioni riguarda le leggi o gli articoli di legge mirati al controllo dell’identità intesa essenzialmente come “potere-dovere” dell’Autorità (Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza) di individuazione-riconoscimento di una persona: vale a dire attribuire ad ella le «esatte e complete generalità anagrafiche» (Intini, 2003, 29), indipendentemente dalla commissione di un reato.
La c.d. “identificazione preventiva”, è intesa più che altro come l’insieme dei dati necessari e sufficienti che permettono di individuare, specie dal punto di vista burocratico e anagrafico, la persona.
Ad esempio L’art. 349, co 2, c.p.p., Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, è un’attività a iniziativa della polizia giudiziaria. L’articolo prescrive che all’identificazione della persona si possa procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici: «La dattiloscopia preventiva cura, pertanto, l’elencazione e l’aggiornamento dei cosiddetti elenchi dei precedenti dattiloscopici, funzionali a molteplici attività di Polizia e, più in generale, di Giustizia.» (Intini-Picozzi, 2009, 319).
Il terzo ambito, che deriva dal secondo ma con alcune significative differenze, riguarda il “controllo sociale”; ovverosia l’insieme di norme poste in essere estendendo l’utilizzo di un dato biometrico a intere categorie di persone (si pensi ad esempio al Testo Unico sull’immigrazione; oppure ai sistemi di protezione per l’accesso a luoghi sensibili come istituti di credito, uffici, ecc.; o ancora alla possibilità di dotare i documenti di riconoscimento di un dato biometrico per impedirne la falsificazione o la sostituzione).
Alla luce di questa e delle precedenti considerazioni, è possibile affermare che l’accertamento dattiloscopico, nel suo complesso, sia sottoposto ad una duplice regolamentazione.
Una prima serie di prescrizioni riguarda l’orientamento giurisprudenziale della Cassazione che a sua volta si fonda su un calcolo statistico-probabilistico.
Una seconda serie di prescrizioni riguarda le leggi e gli articoli di legge mirati a stabilire l’identità intesa essenzialmente come “potere” di individuazione-riconoscimento di una persona e il “controllo sociale” di una intera categoria di persone. Vale a dire attribuire le esatte e complete generalità anagrafiche (Intini, 2003, 32), indipendentemente dalla commissione di un reato.
Le impronte possono dunque essere codificate da un gran numero di funzioni: il flusso delle creste papillari (ma solo per le digitali!); il tipo, il numero, la direzione e la posizione delle minuzie; la morfologia dei pori sudoripari, la loro distanza o il loro numero.
Queste caratteristiche peculiari sono in realtà molte, ma la dottrina giurisprudenziale ne individua generalmente una sola specie che è stata interpretata come “necessaria e sufficiente” per stabilire un’identità dattiloscopica certa: la c.d. differenza derivante dai “punti caratteristici” dei caratteri particolari dell’impronta. In buona sintesi dal numero di minuzie e dalla corrispondenza per forma e posizione. Le ragioni di questa scelta dipendono probabilmente dal fatto che le impronte palmari, al contrario di quelle digitali, non sono soggette a nessun tipo di classifica generale e quindi, in questo caso, non sarebbe possibile stabilire un’identità dattiloscopica certa a partire da quel dato.
In assenza di una norma specifica nell’ordinamento giuridico italiano che regoli la questione dell’identità “giudiziaria” delle impronte repertate sulla scena del crimine, sono stati la dottrina e la giurisprudenza a definirne l’orientamento. Tale ambito è, in via esclusiva, disciplinato da una tendenza giurisprudenziale della Cassazione. La Corte Suprema ha sancito, in tempi successivi, con diverse sentenze, il valore probatorio dell’identità dattiloscopica.
L’orientamento attuale, che richiama una sentenza del Cinquantanove (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, n. 2559 del 14/11/1959), è di considerare l’effettiva corrispondenza tra due impronte quando esse possiedono almeno sedici o diciassette punti caratteristici in comune, uguali per forma e posizione.
In altre parole si procede mettendo a confronto due termini omologhi: l’impronta rilevata sul luogo del reato con quella precedentemente assunta, per stabilire se esistono analogie e corrispondenze. Se vi è una corrispondenza per forma e posizione tra i punti caratteristici delle diverse impronte papillari, e solo in questo caso, è possibile attribuire un’identità dattiloscopica certa.
Un’ulteriore sentenza della Cassazione Penale (Sez. II, n. 11410, del 23/10/1986) ha altresì rafforzato questa verità giudiziaria: “Le risultanze delle indagini dattiloscopiche offrono piena garanzia di attendibilità, senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché evidenzino la sussistenza di almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione tra le impronte digitali dell’imputato e quelle rilevate sul luogo del reato”.
Bibliografia
Balloni A. (1986), Criminologia in prospettiva, Clueb, Bologna.
Ceccaroli G. (2000), Sulle tracce del delitto, Imprimitur, Padova.
Donato F. (2006), Criminalistica e tecniche investigative, Olimpia, Sesto Fiorentino.
Faulds H. (1880, ottobre), On the Skin-furrow of the Hand, rivista scientifica “Nature”.
Galton F. (1892), Finger Print, Mac Millian & Co., London.
Galton F. (1895), Finger Print directory, Mac Millian & Co., London.
Giddens A. (2006), Fondamenti di sociologia, Il Mulino, Bologna.
Intini A. (2003), Investigazione di Polizia Giudiziaria, Laurus Robuffo, Roma.
Intini A.–Picozzi M. (2009), Scienze forensi. Teoria e prassi dell’investigazione scientifica, Utet, Torino.
Loubet Del Bayle J. (2008), Polizia e politica. Un approccio sociologico, L’Harmattan Italia, Torino.
Riley Scott G. (1999), Storia della tortura, Mondadori, Milano.
[1]La traduzione letterale per arch, loop, whorl, è, rispettivamente, “arco”, “cappio”, “spira o vortice”. La figura composite, fu invece menzionata per la prima volta da Edward Henry, nel 1900, ne “Classification and uses of finger prints”. L’equivalente in lingua italiana di questi quattro termini è stato tradotto con i sostantivi “adelta”, “monodelta”, “bidelta” e “composta”, evidentemente per indicare le caratteristiche morfologiche di quelle figure.