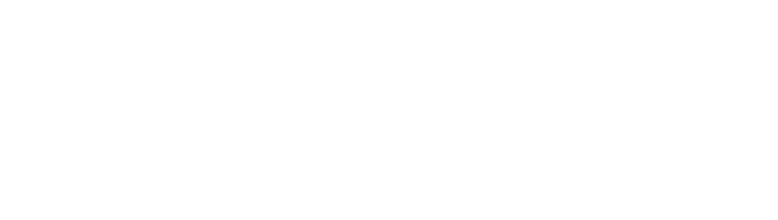La pena di morte in America. Un’anomalia nell’era del proibizionismo
«La pena di morte può sembrare incontestabile per i tradizionalisti impenitenti e per gli sfrenati retributivisti. Tuttavia, la pratica della pena capitale nell’America odierna pone i funzionari e i loro fautori in una contraddizione culturale, obbligandoli a comportarsi in modi che sono, al contempo, legali e trasgressivi. Li intrappola in uno spazio scomodo tra le norme culturali dell’umanesimo liberale e la pratica giuridica di mettere a morte i delinquenti»
D. Garland
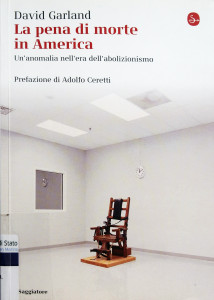
La pena di morte in America. Un’anomalia nell’era del proibizionismo – D. Garland – Ed. Milano, Il Saggiatore 2013
La recente recrudescenza di fenomeni criminosi capaci di suscitare timore e indignazione nella coscienza collettiva continua ad alimentare l’acceso dibattito intorno alla pena di morte, intesa quale unica efficace risposta al disordine sociale provocato dall’autore del reato. L’omicidio crea una cesura assoluta e irreversibile nella compagine sociale all’interno della quale matura, meritevole di essere riparata con un gesto parimenti assoluto e definitivo: la soppressione fisica del reo. Una vita per una vita o, piuttosto, una morte per una morte. Eppure, come osservano gli abolizionisti, appare quantomeno contraddittorio il tentativo della società di proteggere la vita dei consociati mediante l’uccisione di alcuni di essi, sebbene a seguito di una condanna legittimamente inflitta. Il potere costituito finirebbe per rendersi complice di quello che M. Alain Peyrefitte ha definito un «omicidio premeditato», perpetuando la medesima spirale di violenza che ha armato la mano dell’omicida. Una palese incongruenza, insomma, rispetto alla dichiarata necessità di tutela della vita umana. Inoltre, una sanzione penale dall’esito irreversibile presuppone una giustizia certa e infallibile.
Ebbene, il lettore che si accostasse all’opera di Garland alla ricerca di simili contenuti ne rimarrebbe senz’altro deluso. Lungi dal passare in rassegna le molteplici argomentazioni che i sostenitori e gli oppositori della pena capitale sviluppano o, viceversa, combattono al fine di pervenire ad una risposta definitoria, l’Autore sceglie una singolare prospettiva di analisi, che gli consente di tratteggiare l’evoluzione di un istituto, il quale – per quanto disumano, anacronistico ed inefficace possa apparire agli occhi degli Europei – negli Stati Uniti rappresenta tutt’altro che un barbaro retaggio del passato. L’oggetto della sua ricerca viene finemente scandagliato attraverso la lente imparziale dell’analisi sociologica, scevra da valutazioni etiche o morali e tesa, piuttosto, a «descrivere e spiegare nel dettaglio il peculiare istituto della pena capitale americana, in particolare la sua relazione con la società che lo sostiene» (p. 35). L’idea di fondo che ispira il volume è la convinzione che la pena di morte, negli Stati americani in cui è rimasta in vigore, meriti di essere considerata alla stregua di un «fatto sociale» (p. 27) e come tale debba essere spiegata. Una questione sociologica, dunque, e non di natura filosofica, giuridica o morale, le cui forme e funzioni impongono un’indagine concreta, hic et nunc dell’istituto: la pena capitale con i suoi processi di attuazione e di esecuzione, in un dato luogo e in un dato tempo. In tal senso, merito incontestabile dell’opera è lo scivolamento della riflessione sulla pena di morte dal piano del dover essere – imperativo morale e giuridico di kantiana memoria – a quello dell’essere, drammaticamente contingente. Solo un simile approccio è in grado di indagare le ragioni della sua persistenza nello Stato americano, tradizionalmente caratterizzato da alte percentuali di violenza interpersonale e dalla delega del magistero punitivo pubblico a istituzioni democratiche locali, di impronta populista.
La pretesa di oggettività dell’approccio metodologico di Garland è certamente garantita dall’impeccabile ricostruzione storica dell’istituto, che ne evidenzia la forte connotazione politica e culturale sia nella cornice europea sia in quella statunitense, seppur con le diversità figlie delle rispettive tradizioni giuridiche e delle innumerevoli ambivalenze, addirittura presenti nel medesimo contesto geografico. Basti pensare alla differenziazione subnazionale che caratterizza i cinquanta Stati dell’Unione nei processi applicativi della pena di morte – in trentacinque di essi, la medesima è contemplata nel sistema sanzionatorio vigente, così come nel diritto penale federale e nel codice militare – e che, in termini di diritto comparato, è vivace espressione di quell’«eccezionalismo americano» (p. 27) del tutto inusuale presso le moderne nazioni non abolizioniste. Un’analisi lucida e imparziale della trama all’interno della quale, per secoli, ha prosperato la pena di morte fino al suo declino, nei Paesi europei, e ai processi trasformativi che ne hanno ridisegnato la fisionomia, nell’America contemporanea. Al lettore che, legittimamente, contestasse la pretesa neutralità del ricercatore, fa eco Adolfo Ceretti – uno dei più autorevoli commentatori di Garland nel panorama criminologico italiano – nella Prefazione al testo, laddove puntualizza che «(l)a posta in gioco […] non riguarda tanto il prendere o meno posizione rispetto a un tema in discussione, quanto il non nascondere da che parte si è veramente schierati» (p. 13). E, sebbene l’Autore non si professi né favorevole né contrario alla pena capitale – coerentemente, avverte Ceretti, l’opera non può dirsi «né un’apologia né una critica della pena di morte» (p. 13) – lascia intendere, senza equivoci, il suo orientamento a quanti si cimentino nella lettura della sua ultima, eccellente opera.
Senza prestare il fianco ad argomenti faziosi, Garland guida il lettore in un affascinante viaggio attraverso secoli di storia americana, ponendo in relazione le peculiarità di un istituto sanzionatorio – quello della pena capitale, appunto – con le caratteristiche socio-culturali della popolazione statunitense: dal culto dell’individuo alla mancanza di solidarietà sociale; dalla persistenza di conflitti di stampo razziale al localismo e all’antistatalismo, prerogative di una nazione che privilegia gli attori politici locali assai più di quanto accada negli altri Paesi occidentali. Ne consegue un significativo ampliamento dell’oggetto d’indagine, che si dilata progressivamente fino ad abbracciare tutti i protagonisti della «drammaturgia dell’esecuzione» (p. 174): dai giudici alle giurie popolari, dai rappresentanti politici ai mezzi di comunicazione di massa, dal condannato alle associazioni delle vittime, in un crescendo di suggestioni simboliche ed emotive gestite, con sapiente maestria, dalla penna dell’Autore. Un campo sociale quanto mai articolato quello nel quale si intersecano i modelli di azione che plasmano la «morte all’americana» (p. 67), in un oscillare incessante tra il consolidamento di una prassi esecutiva priva di sofferenza – efficienza del metodo è la parola d’ordine – e la ricerca di nuovi significati politici e culturali da attribuire alla pena capitale, ora che la sua efficacia deterrente appare definitivamente smentita dai fatti.
In modo meticoloso e ampiamente documentato, il saggio risponde ad un triplice interrogativo: perché la pena capitale continua a sopravvivere nella vita pubblica statunitense, rivelando radici di possente vitalità? È sufficiente appellarsi alla «collera suscitata dalle alte percentuali di omicidi […] e da disposizioni normative […] che insistono sulla retribuzione severa» (p. 214) o è necessario invocare codici politici e culturali da tempo cristallizzati nella società americana? E ancora: perché i processi di trasformazione che hanno condotto alla completa abolizione dell’istituto in Occidente non hanno prodotto il medesimo risultato in America? Ma l’opera apre anche inquietanti scenari relativi alle funzioni secondarie dell’istituto, come la canalizzazione di condotte aggressive socialmente deprecabili in una sorta di sostituzione vicariante legalizzata, che consente di sfatare il tabù della morte nel discorso pubblico statunitense. Come osserva acutamente Ceretti, la pena capitale dell’America del XXI secolo si fa «produttiva, performativa, generativa […] un’incitazione a parlare della morte» (p. 19) – secondo un’espressione cara a Foucault – che permette alla collettività e ai suoi rappresentanti politici di formulare un discorso altrimenti foriero di ansie e di pudori.
La pena di morte in America propone un’originale chiave di lettura dell’istituto sanzionatorio più controverso della penologia contemporanea, ipotizzandone una metamorfosi che, da strumento di governo statale e di giustizia penale, lo ha progressivamente trasformato in «una risorsa per lo scambio politico e il consumo culturale» (p. 346). Avvincente e convincente, l’opera di Garland invita il lettore alla momentanea sospensione del giudizio etico intorno alla pena di morte, per comprenderne origini, paradossi e contraddizioni nel tessuto socio-culturale della prima potenza economica e militare mondiale.