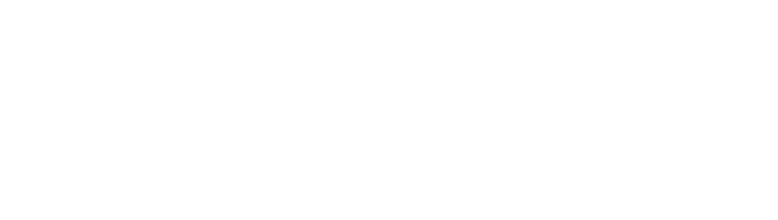La Relazione
La parola relazione trae origine dal latino relatio-onis: il suo primo significato fa riferimento all’azione di riferire su di una situazione o su di uno stato di cose. Una seconda accezione ben più generica invece la descrive quale rapporto che collega, in maniera essenziale o accidentale, due o più cose, fatti, concetti[1].
Nell’ambito filosofico, il concetto di relazione è sicuramente tra i più problematici, già al tempo di Aristotele: la locuzione πρόςτι (letteralmente “rispetto a qualcosa”), già utilizzata nella terminologia platonico-accademica, viene da lui inserita tra le 10 categorie del pensiero «ossia dei predicati generalissimi della realtà[2]».
Diverse, quindi, le interpretazioni: la Relazione può intendersi come categoria filosofica, come un concetto matematico, giuridico piuttosto che linguistico.
Tra tutte, quella che interessa trattare in questa sede sarà la Relazione in senso interpersonale, quale dimensione socio-antropologica intesa come processo di creazione del sé non solo da un punto di vista cognitivo, quanto anche affettivo ed emotivo. Relazione come legame che si crea tra due o più persone i cui pensieri, sentimenti e azioni si influenzano vicendevolmente, secondo una logica di pura interdipendenza.
Nel corso della storia le relazioni interpersonali hanno subìto dei radicali mutamenti: le trasformazioni storico – politiche ed economiche, insieme alla rivoluzione tecnologica, hanno profondamente modificato il nostro modus relationandi.
Proveniamo da una società delle cd “grandi narrazioni” (Lyotard, 1979) definita da regole e schemi comuni e ai quali tutti erano chiamati a conformarsi, per approdare ad una società globale e globalizzata dove l’umanità è libera di vivere a proprio modo le relazioni con gli altri, di scegliere le persone con le quali relazionarsi e di esplorare nuovi e diversi modi per poterlo fare.
Ed è con questa società che ci relazioniamo, una società dove sempre meno si usa la parola Uomo e Persona, sempre più quella di Chiunque, seguendo una logica di maggior liquidità e neutralità (Bauman, 1992).
Con il crescere delle libertà, è cresciuto anche il disagio esistenziale: i ruoli sociali e sessuali, il senso d’identità sono entrati in crisi; è aumentata la conflittualità e il rapporto tra istituzioni e cittadini è sempre più improntato sulla sfiducia; la famiglia è in disfacimento, come pure la solidarietà e la coesione sociale. In progressione la spirale disfunzionale di relazioni vissute sempre più come complesse, sempre più incomprensibili, apparentemente impossibili nella loro risoluzione.
È cambiato il concetto stesso di relazione, di legame e tale mutamento ha lasciato un profondo vuoto che incrementa il senso di disagio e di conflittualità generali. Perché?
Parafrasando Recalcati[3], la vita di ognuno di noi si concretizza attraverso un instancabile esercizio di mediazione con l’Altro. Posso diventare ciò che sono o voglio essere, solo passando dalla mediazione/relazione con l’Altro, che può intendersi quale famiglia, istituzioni, società, cultura, lavoro etc.
L’oggi è caratterizzato principalmente da una profonda crisi dell’alterità e della sua funzione di mediatore per la creazione del sé: l’Altro appare sempre più un intruso, di cui aver paura, di cui non è bene fidarsi, da tenere lontano.
Qualche esempio: assistiamo ad una perenne e sottile contesa tra Scuola e Famiglia, tra le quali l’assunzione di una posizione educativa della prima può suscitare nella seconda il sospetto di un esercizio di un potere arbitrario. Viviamo in una realtà sempre meno reale e sempre più virtuale: a scuola, a casa, al ristorante, in palestra, al cinema, non c’è contesto di vita che non abbia come intermediario di qualsiasi vicenda od esperienza, anche emotivo-affettiva, il mondo dei social e del web. Quindi bypassando totalmente il confronto e la relazione con l’altro. Il mondo del lavoro è sempre più stressogeno: burn-out, mobbing da un lato, crescente competitività, eccessiva burocrazia dall’altro sono alcune delle disfunzionalità della relazione lavorativa, vissuta sempre più con ansia, preoccupazione quindi conflittualità. Sono cambiate, per di più, anche la sintomatologia della sofferenza umana: anoressia, ortoressia, depressione, web e sex dipendenza, tossicomanie. Milioni di giovani e giovanissimi che volontariamente si sono auto-rinchiusi nelle proprie camere, spezzando ogni legame con la vita, ritirandosi da essa (Lancini, 2015). Rifuggendo il legame sociale, la relazione appunto, quasi fosse lei stessa una malattia, comunque “fonte di disagio[4]”.
Cosa fare, allora, a quale antidoto rifarsi?
Principalmente all’Ascolto: di sé prima, dell’altro poi. Essere in relazione significa prima di tutto mettersi in ascolto. Il male di oggi, difatti, è quello di saper poco ascoltare: siamo tante isole, mondi solitari immersi in un oceano di indifferenza, diffidenza e sfiducia.
La dimensione dell’ascolto è fondamentale perché esperienza strutturante il proprio sé e, allo stesso tempo, una condizione essenziale per lo sviluppo di una buona relazionalità[5].
Saper ascoltare l’altro significa prima di tutto sapersi ascoltare: il vero scoglio, dice Di Benedetto (1991) «non è capire, ma far risuonare in noi le parole dell’altro, nel mentre ascoltiamo noi stessi». Viviamo un mondo imperniato di narcisismo che si traduce da un lato in una paranoicizzazione della realtà (Lancini M., 2015), dall’altra in un’attenzione tossica alla propria soggettività: tossica perché ha lentamente perso il termine di paragone quale necessariamente è l’Altro.
Nella società odierna dominata dall’idolatria dell’audience, stiamo rendendo fluidi sia l’ascoltare se stessi che l’ascoltare l’altro e l’essere dall’altro ascoltati. Ognuno di noi, invece, si porta dentro il bisogno di vivere tutte e tre queste esperienze: se viene meno anche solo una di esse, corriamo il rischio di diventare stranieri a noi stessi e all’altro[6].
È dal riconoscimento dell’altro che nasce una maggiore consapevolezza di sé e si sprigionano le potenzialità terapeutiche dell’ascolto. Vivere la relazione è ascoltare sé nell’altro, lasciandolo entrare in casa nostra, nella nostra intimità.
Dopo l’ascolto di sé e dell’altro nulla rimane come prima: la palude buia e stagnante dove potevamo trovarci si tramuta in una sorgente zampillante in costante rinnovamento che promuove le proprie risorse e contemporaneamente quelle del soggetto o dei soggetti con i quali siamo in relazione.
Roger sosteneva: «l’uomo non ha semplicemente le caratteristiche di una macchina, non è semplicemente prigioniero di motivi inconsci; è una persona impegnata a creare se stessa, una persona che crea il significato della vita, una persona che incarna una dimensione di libertà soggettiva[7]».
Ed è in questa dimensione di creatività e di fiducia che possiamo ben vivere l’ascolto e la relazione con noi stessi, con chi ci sta vicino, finalmente in modo autentico, in una parola vero.
[1]http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/relazione/
[2]Aristotele, La Metafisica, Libro V
[3]Recalcati M., Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre, Feltrinelli, 2013.
[4]Ibid p. 65.
[5]http://www.dehoniane.it:9080/komodo/trunk/webapp/web/files/riviste/archivio/05/20111330.htm
[6]Castellazzi V.L., Ascoltarsi, Ascoltare. Le vie dell’incontro e del dialogo, Magi edizioni, 2011.
[7]Rogers C., La terapia centrata sul cliente, Giunti, Firenze, 2013.